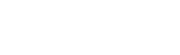STEFANO LOCATELLI | In questi due mesi abbiamo assistito a un proliferare di appelli e proposte per la riapertura dei teatri o, quanto meno, per interventi economici a sostegno degli “artisti” (categoria per definizione precaria anche quando lavora per Istituzioni che possono vantare una certa stabilità di strutture e mezzi economici).
Tutto sacrosanto, perché il teatro è irrinunciabile, è necessario, è un servizio pubblico, è un bene comune.
Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. Ma il fatto che si senta in continuazione la necessità di ripeterlo non è un buon segno.
Perché forse ciò che è non è davvero ciò che sembra. Lo scollamento tra percezioni, volontà, proposte degli uomini di teatro e quello che dovrebbe essere il potenziale pubblico dei teatri non è mai stato, negli ultimi cinquecento anni, così forte.
Oggi, ancor più di due mesi fa, credo sia anzitutto urgente prendere finalmente coscienza che il ruolo dello Stato come garante di un’idea di teatro come servizio pubblico potrà continuare ad avere senso solo se vi sarà in futuro una percezione del teatro come bene irrinunciabile per la collettività.
Questo è un nodo cruciale, specie in momenti di gravissima crisi economica (come è quella che stiamo già vivendo e soprattutto ci apprestiamo a vivere nell’immediato futuro). Potrà sembrare un punto ovvio, ma forse non lo è, nel momento in cui il teatro appare alla grande maggioranza delle persone non come un gesto antico capace di parlare le lingue del contemporaneo, ma come qualcosa di antiquato, al limite di museale, magari condannato alla definitiva rimozione dai nostri orizzonti culturali.
Per questo, purtroppo, non basta più (e non basta da molto tempo ormai) enunciare la necessità del teatro per garantirne la persistenza nell’ambito di ciò che deve essere considerato di utilità pubblica. Tanto meno sarà sufficiente aumentare o diversamente articolare l’attuale supporto economico dello Stato in assenza di una condivisa percezione del teatro come bene comune.
Potrà sembrare un paradosso, ma forse parliamo sempre troppo di Cultura, de LA Cultura; di quella cosa che si dice tutto attaccato: Lacultura. Un po’ come quando si parla dell’Europa, che poi diventa Leuropa. Insomma una entità, che sta sopra di noi, magari pure per la quale vale la pena morire ma ancora non abbiamo capito esattamente perché.
Io stesso, che che di lavoro faccio il professore in “discipline dello spettacolo” all’università, mi rendo conto di parlare troppo spesso di contenuti, di estetica, di drammaturgia, di storie e Storia, ma raramente mai davvero dello spasso e dello sconquasso dell’esperienza teatrale.
Che forse abbiamo irrimediabilmente perduto, ma era la componente fondamentale che portava e riportava gli spettatori (dal cardinale al popolano) ai comici e sopratutto comiche dell’arte, o ai grandi attore e grandi attrici dell’Ottocento, o ancora a Totò e Eduardo.
Tutti gli uomini e donne di teatro ancora oggi fanno grandi sforzi per tentare di ribadire l’irrinunciabilità della relazione teatrale ma, diciamoci la verità, quando va bene il teatro è ancora percepito dal senso comune come un cinema vecchio, o per i più illuminati è una matrice importante che non puoi non conoscere perché fa parte appunto della Cultura.
Ma se ripercorressimo anche velocemente la grande storia del teatro degli ultimi cinque secoli, ci potremmo rendere facilmente conto che gli uomini e donne di teatro, dai comici dell’arte, passando per Shakespeare e Molière, da Goldoni e via fino a Eduardo, non pensavano certo anzitutto al teatro in termini di Cultura quando preparavano i loro spettacoli; non che mancasse loro totalmente una categoria simile, ma essa veniva semmai solo dopo, non come premessa giustificante ma solo come strategia personale di accreditamento e normalizzazione in società.
Soprattutto nella percezione comune il teatro non era propriamente Cultura, era anzi addirittura spesso considerato immorale, però gli spettatori amavano i teatranti, non potevano letteralmente farne a meno, non tanto o non solo per le storie che portavano in scena, ma di loro proprio in quanto corpi e menti, perché stare con loro era uno spasso e uno sconquasso, qualcosa in fondo di molto simile alle conseguenze fisiche e mentali dell’innamoramento erotico.
Non poterne fare a meno.
Siamo così sicuri che gli italiani non possano più fare a meno del teatro?
Forse proprio la categoria Cultura, dentro cui è stato ficcato il teatro negli ultimi sessant’anni almeno, ha avuto come risultato che esso viene percepito collettivamente da troppo tempo non per quello che è ed è sempre stato, ma per la gran coda da pavone che si porta dietro: appunto La Cultura, che poi per molti diventa sinonimo, e non sempre a torto, di noia o gran rottura di balle.
Ovviamente non sostengo che si debba far fuori il teatro dalla categoria “Cultura”. Sarebbe un passo indietro anziché uno avanti.
Ma cerchiamo di non limitarci a dire che il teatro “è un bene culturale” quindi va sovvenzionato, va sostenuto, va anche protetto come il panda.
Questo lo sanno tutti gli addetti (a vario titolo) ai lavori. E’ bello ripeterselo, ma pensiamo davvero possa ancora essere sufficiente?
Quando poi milioni di persone rischiano di non avere soldi per fare la spesa tutti questi discorsi possono essere facilmente e definitivamente spazzati via dalla fame, dall’urgenza di dover sostenere in via prioritaria attività e servizi ancora collettivamente percepiti come irrinunciabili, specie in un peculiare contesto economico fondato sulla scarsità di risorse finanziarie.
Che ora, subito, serva un sostegno finanziario eccezionale al teatro, e al mondo dello spettacolo in genere, è senza dubbio fuori discussione.
Va dato, questo sostegno, senza se e senza ma.
Se ci limiteremo però a preservare il panda, senza cambiare nulla, avremo solo dato un calcio in più al barattolo. E in poco tempo ci si ritroverà a stare non meglio di prima.
Provo a individuare alcune questioni che potrebbero, almeno nel medio medio periodo, essere utili.
Uscire da una logica offertista
Dalle modalità di intervento della mano pubblica, e anche troppo spesso dai discorsi e dalle richieste precise degli operatori, pare che la richiesta e volontà di sostegno da parte dello Stato sia fondata sulla pia illusione che l’offerta di spettacolo (ovviamente di qualità, d’arte, ecc. ecc.), cioè la produzione, possa in qualche modo anche generare la domanda di spettacolo. Cui si accompagna un’altra illusione, cioè che debbano e possano essere i teatri, a latere delle produzioni, a generare “domanda” occupandosi della “promozione del pubblico” (per altro terminologia propria del marketing, e che alla fin fine del marketing – ovvove! – assume molte caratteristiche).
Basterebbe rileggersi ogni tanto John Maynard Keynes: non è l’offerta che crea la domanda, ma è la domanda che genera l’offerta (J.M. Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, libro I, cap. III), come avviene in tutti i fatti umani che hanno a che fare con la componente economica che sta alla base di qualsiasi scambio (anche di beni immateriali).
Sarà in quest’ottica centrale la questione del PUBBLICO.
Questo mi pare un nodo centrale: se non c’è davvero una comunità, locale o nazionale, che (per mille svariate ragioni a partire dall’assenza del teatro dall’orizzonte culturali dei cittadini) domanda spettacoli teatrali, non ha senso produrre sempre di più, o in modo diverso, o proponendo magari gruppi “ggggiovani” (i famosi under 35), pensando addirittura che poi il pubblico “gggiovane”, o forse in attesa di diventare giovane, decida di andare a teatro.
Del resto, non è che se un barista, accorgendosi che il suo bar è sempre vuoto, si mette a fare un caffè dietro l’altro e li posa in fila sul bancone del bar, allora entreranno all’improvviso dei clienti a bere quei caffè…
La promozione del pubblico non è e non può essere formazione del pubblico
Non ha molto senso nemmeno fare la promozione del pubblico, pensando che essa significhi anche formazione del pubblico.
Di base, la formazione del pubblico è un compito inevitabilmente al di fuori della portata di chi produce spettacolo dal vivo, e dovrebbe essere considerato inaccettabile come compito che surrettiziamente lo Stato italiano tende a demandare alle istituzioni teatrali.
Togliamoci una volta per tutte la puzza culturaloide da sotto il naso. Se si fa la promozione la si faccia bene anzitutto per quello che è, cioè una articolazione di quel marketing che troppo spesso si sente la necessità di mascherare e a volte giustificare con qualche principio di etica comunitarista.
La formazione è tutta un’altra storia. Forse il Teatro alla Scala dovrebbe occuparsi anche di insegnare gratis musica a tutti i suoi potenziali spettatori? Sarebbe, in fondo, come pretendere che la Fiat, oltre a produrre e promuovere automobili, debba anche occuparsi di insegnare a guidare ai potenziali acquirenti delle proprie auto.
Per quanto riguarda gli ambiti dell’Arte e della Cultura riconosciuti dallo Stato come di interesse pubblico, la formazione dei cittadini ai fondamenti dei linguaggi, della storia e delle forme dell’arte non può che essere di competenza dello Stato, anzitutto attraverso quel primario veicolo di formazione che è garantito dalla Costituzione, cioè la Scuola.
Se davvero sentiamo l’esigenza di riaffermare che il teatro è Cultura non possiamo dimenticarci di questo.
Ma, purtroppo, non si sente abbastanza, anche da parte degli operatori teatrali, chiedere un deciso intervento politico sulla scuola in generale, dove si dovrebbe (come avviene in molti altri Paesi), introdurre il teatro come materia curricolare.
Lo stesso in fondo vale anche, e forse a maggior ragione, per la musica: siamo la patria del melodramma, dell’opera lirica, del pianoforte (ecc. ecc. ecc.) e dunque più che giustamente spendiamo centinaia di milioni di euro del FUS, e non solo, per finanziare la musica e l’Opera ma, al contempo, nelle nostre scuole (e il tutto per altro limitato sostanzialmente alla primaria e alla scuola media) si fa poca storia e pochissimo ascolto musicale e, quel che è peggio, spesso si impara a odiare la musica perché costretti a zuffolare quattro note in classe con l’odioso piffero (detto anche flauto dolce); quando l’esercizio dello strumento si protrae a casa, spesso l’odio per la musica viene alimentato pure tra i genitori e i vicini di casa.
Non basta certo pensare al teatro nella scuola alla maniera della cosiddetta “Buona Scuola” (e relative linee guida), ovviamente a “costo zero”, che alla fine ha continuato a relegare, quando va bene, una attività che doveva diventare “curricolare” all’orario post-pomeridiano da dedicare alle attività facoltative (i bambini stanno, in tempi normali, già a scuola dalle 8.30 alle 16.30, e io stesso, che pure insegno una cosa che si chiama Storia del teatro all’Università, troverei brutale lasciare mia figlia a fare il laboratorio teatrale ancora tra quattro mura dalle 17 alle 19; preferisco mandarla a buttarsi tra le pozzanghere al parco, o a giocare a Tennis, come per altro suggeriva Mejerchol’d ai suoi attori).
In fondo, si tratta sia di una questione di istruzione dei cittadini ma anche di introdurre, tramite la Scuola, una generale e massiva preparazione ai linguaggi del teatro e della musica e dell’arte, che avrebbe come ricaduta naturale proprio la domanda di teatro, la creazione di un pubblico, dunque di una domanda e di un mercato naturale per il cosiddetto spettacolo dal vivo.
Non intendo ovviamente un pubblico di studenti delle scuole, come i molti che negli anni sono stati costretti e deportati a vedere la qualunque (non di rado con battesimi teatrali tanto devastanti da allontanare per sempre dal teatro); intendo proprio un vasto pubblico di cittadini, formato nel tempo (se vogliamo per generazioni) ai linguaggi artistici, con adeguati insegnanti, strumenti, orari e metodi di apprendimento nelle scuole italiane, che sentirà la normale esigenza e necessità di frequentare i teatri, le sale da concerto, l’opera lirica.
Del resto, se noi consideriamo ancora valida l’idea di teatro come pubblico servizio, non possiamo non evidenziare che solo uno Stato può essere nelle condizioni di fare reali investimenti in un’ottica di trenta/quaranta/cinquanta anni, magari uno Stato che abbia la consapevolezza che il più importante investimento per il futuro non è solo quello che può essere fatto oggi sul tessuto produttivo, ma anche quello che ha a che fare con il sistema di istruzione e di educazione dei cittadini.
Il diritto di essere artisti non esiste
Sono ragionevolmente convinto che chi riceve una buona e generale formazione culturale in ambito artistico, musicale, se vogliamo anche teatrale, sin da bambino senta poi paradossalmente meno, una volta adulto, la necessità di buttarsi a un certo punto a capofitto nel “mondo dell’Arte”. Ha già sperimentato la pancia piena, e poi sa come procurarsi quel particolare cibo di cui non può fare a meno.
C’è invece poi la fame atavica di “arte” che compare improvvisa attorno ai 18-19-20 anni. Spesso anche dopo. Ho conosciuto centinaia se non migliaia di studenti che vogliono lavorare nei più vari ambiti dello spettacolo. Il problema è che vogliono in troppi fare gli “artisti”, pur partendo spesso da una base di formazione universitaria non certo pensata (e non pensabile) come una accademia teatrale.
Chi vuole “fare l’artista” sembra snobbare, in particolare, un po’ tutta la formazione specialistica nell’ambito della economia e organizzazione dello spettacolo, del cinema, dell’arte, della cultura.
Chi lavora in questo specifico settore della formazione si trova a volte davanti persone con un curriculum notevole (e già di sicuro interesse per i molti che sono alla ricerca di bravi organizzatori), indecise se effettivamente seguire la strada di quelli che una volta venivano chiamati “operatori culturali”, perché, “inzomma, io vorrei fare l’artista e non lo sterile organizzatore”… In questi casi basta anche solo raccontare chi era, cosa ha fatto, e quale incidenza culturale e pure artistica ha avuto uno come Paolo Grassi sul teatro italiano, per aiutare le persone a fare quello che veramente vogliono fare.
Ma non è sempre così semplice.
Il vero e puro “artista” nemmeno si pone il problema. Troppo grande e diffuso il desiderio di fare, o meglio di “essere artisti”.
Forse anche il diritto di essere artisti?
Il cortocircuito tra reality-show tipo Amici, X-Factor (ma forse pure il Grande Fratello e Uomini e donne), la sub-cultura dei gloriosi centri sociali di una volta, alla Leoncavallo, e la retorica qualunquista dell’uno vale uno, ha cresciuto una generazione che sembra aver incorporato una idea artistoide di artista.
Il dandy e lo sciamannato si ritrovano oggi a braccetto a sognare una rivoluzione culturale dal basso, tra osterie abusive, corsi, laboratori, spettacoli, rave e produzione di birrerie artigianali, per tutti, ma per favore a pagamento e cash, nella miriade di spazi occupati che pullulano nelle nostre città.
A che serve studiare l’economia, la legislazione, come funzionano l’organizzazione, la progettazione e la produzione di festival e spettacoli dal vivo (figurarsi il marketing – ovvove ovvove!), quando puoi fare l’artista “a buffo”, senza agibilità, senza borderò. Basta “crederci”, “avere fiducia”, “stare sul pezzo”; poi l’economia circolare e solidale farà il resto, e se ti staccano la corrente arriverà un cardinale che si tufferà in una cabina elettrica a riallacciarla. In questi casi l’artista anarcoide può anche diventare teologo: “sta scritto nel Vangelo”; oppure più di recente arrivare a proporre una estensione allo spettacolo dei regolamenti per la riapertura dei luoghi di culto facendo leva sull’analogia “ministri, concelebranti, organisti” / “artisti, tecnici, musicisti”, “fedeli” / “spettatori”. Tutto vero per altro, giustificabile con ottime ragioni storiche, religiose e antropologiche, ma suona così strano questo peculiare richiamo all’applicazione di norme e regolamenti in bocca ad artisti “puri”, artisti “a ogni costo”, artisti per l’arte ma anche “per tutti”, “indipendenti”, “interculturali” e “popolari”, “poli-multi-inter-disciplinari”, impegnati a ridisegnare un presente ostile, perché anche le istituzioni “se ne fregano”, e a progettare per anni il futuro in “beni comuni cantieri di rigenerazione urbana”, ma in sfregio a norme, leggi, prescrizioni previste per tutti i luoghi di pubblico spettacolo e somministrazione di cibo e bevande.
Ma siamo, si sa, in un’epoca di ibridazioni: un mix tra culto popolare dei Santi Patroni, immaginario dei supereroi alla Marvel, e il mito del Che Guevara stampato sulle magliette, connota oggi i discorsi di dandy e sciamannati a braccetto.
A qualcuno sembra una rivoluzione, ma forse è solo un'altra delle forme possibili di arretramento e precarizzazione del lavoro artistico. Oltretutto la prima evidente paradossale conseguenza è che questi luoghi e queste comunità alternative, che dovrebbero rigenerare le città e l’arte, fanno in prima battuta una efficace concorrenza sleale agli spazi regolarmente autorizzati. Nessun teatro “a norma”, anche il più piccolo e pauperista, potrà mai operare vicino a chi non deve pagare vigili del fuoco, stipendi e contributi previdenziali e assistenziali, iva, affitto, bollette delle utenze ecc.
E ciò che si dovrebbe forse proprio ora evitare è (come per altro già succede) che artisti veri, che potrebbero e dovrebbero poter lavorare con regolarità e continuità in un Paese che fosse davvero capace di sostenere le libere attività culturali, si ritrovino a pensare che, se tanto si deve comunque vivere in una economia della miseria e con scarsissime tutele, allora tanto vale rifugiarsi nell’abuso e nella illegalità, e tirare a campare in un luogo da un certo punto di vista protetto e libero, anche forse alla fine con la possibilità di qualche entrata economica, in nero.
Dare possibilità a tutti. Ripensare le modalità del sostegno pubblico.
E’ anche però vero che tutti, davvero tutti, devono avere se non il diritto almeno la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni artistiche. Chi vuole e pretende di essere artista dovrebbe poterlo fare? Certo che sì. Diamo allora soldi a tutti? Regolarizziamo anche i luoghi occupati riconoscendoli come di interesse pubblico e dandogli un contributo FUS?
Fosse anche possibile, e giusto, sarebbe paternalistico.
Anche tenendo conto della particolare situazione in cui ci troviamo, che cosa realmente servirebbe ora? Cosa fare subito?
Mi vengono in mente:
1) Spazi per il teatro da rivedere radicalmente nella loro articolazione interna per garantire il distanzionamento sociale, con eventuali costruzioni di nuovi spazi, anche all’aperto.
Lo Stato dovrebbe dunque intervenire con risorse staordinarie, al fine di ristrutturare, rivedere, finanche costruire spazi teatrali, attrezzarli adeguatamente. Il passaggio successivo, specie per nuovi spazi (o vecchi spazi in disuso ma adeguatamente rimodernati) potrebbe essere metterli a disposizione, anche in concessione gratuita per un certo numero di anni, tramite bandi pubblici.
2) Diverse e più inclusive modalità di sostegno pubblico.
Realizziamo finalmente uno dei sogni di Paolo Grassi. Basta sovvenzioni a tanti, troppi, tutti. Passiamo invece, per quasi tutti, a forme di sostegno indiretto, introducendo sostanziali e magari spudorate forme di detassazione.
Si potrebbero per esempio prevedere diffusi crediti di imposta. Si potrebbe addirittura pensare di raddoppiare il FUS (o diciamo qualcosa di simile ma profondamente rivisto nelle sue regole di funzionamento) e accogliere nelle maglie almeno il doppio delle attuali realtà attraverso l’erogazione a tutti i beneficiari di metà dei contributi non in denaro sonante ma in crediti di imposta. Ma un particolare tipo di credito di imposta, cioè il credito di imposta trasferibile: significa, per semplificare, che io soggetto che ho 100 euro di credito di imposta, posso usarli sì per pagare tasse e imposte (comprese tasse e contributi per i miei dipendenti e collaboratori), ma posso anche trasferire questo credito a un terzo (che so, un fornitore, che invece di pagare solo in euro pago anche col credito di imposta, che poi questo fornitore potrà usare a sua volta per pagare le proprie tasse, le tasse dei dipendenti o anche userà per pagare a sua volta altri fornitori e via dicendo).
La stessa logica andrebbe seguita a livello locale, cioè comuni province e regioni dovrebbero finanziare allo stesso modo: 50% contributi in denaro e 50% in crediti di imposta trasferibili.
Questo sistema potrebbe portare alcuni vantaggi: a) abbandonare finalmente la logica della "mancia" di matrice fascista; b) una maggiore flessibilità di contributi al settore da parte dello Stato, che potrebbe anche facilmente fare leva, alla francese, sulla “eccezione culturale” per giustificare meno vincoli di bilancio su questa voce di spesa; c) creazione di un circolo virtuoso: i soggetti finanziati sarebbero incentivati a trovare quanto più possibile modalità per un impiego profittevole dei contributi (al fine di pagare tasse col credito di imposta); si potrebbe oltretutto definire criteri di utilizzo del credito di imposta a vantaggio soprattutto del personale artistico impiegato.
I soggetti beneficiari, tra l’altro, sarebbero poi incentivati a rivolgersi a fornitori interessati a ricevere come forma di pagamento un credito di imposta (soprattutto imprese locali nel caso di credito di imposta ricevuto da enti locali, imprese italiane nel caso di credito di imposta ricevuto dallo stato centrale. O al limite anche a imprese estere che siano interessate poi a pagare con credito di imposta fornitori italiani e così via).
Tutto ciò che conseguenze ha? Maggiore efficienza, magari qualche spreco in meno ma, soprattutto, forte incentivo all'economia che gravita nel e attorno al settore.
Facciamo un esempio micro, su un comune e un teatro (ma poi la cosa in grande vale a livello nazionale).
Prendiamo una grande città e magari e un grande teatro nazionale di quella città.
Poniamo sia 1 milione di euro il contributo che il Comune dà al Teatro.
Verranno erogati 500.000 euro tramite traferimenti di denaro e 500.000 euro in credito di imposta trasferibile.
Con questi 500.000 euro di credito di imposta quel teatro può:
1) Pagare le addizionali comunali IRPEF di tutti i suoi dipendenti residenti in quel Comune e pagare tutte le tasse che deve al Comune.
2) Pagare una quota parte degli stipendi dei suoi dipendenti residenti nel Comune (che poi a loro volta li potranno immediatamente usare per pagare la tassa dei rifiuti, l'IMU, le multe... insomma, qualsiasi imposta o debito nei confronti delle casse comunali che i dipendenti devono pagare, ma anche qualsiasi servizo di imprese locali interessate a ricevere credito di imposta come pagamento.)
3) Pagare, anche solo con una quota parte della spesa, fornitori locali (interessati quindi ad avere un credito di imposta con cui pagare le tasse comunali). Tutto questo va a incentivare l'economia locale. Mettiamo che quel Teatro debba comprare materiali e strumentazione tecnica per 20.000 euro. Non ha più in cassa solo denaro liquido da spendere bensì molti crediti di imposta. Potrà dunque pagare la commessa con 10.000 euro liquidi e 10.000 euro con credito di imposta. Magari, invece di affidarsi a un fornitore di una città lontana sarà incentivato a chiedere preventivi ad aziende attive nel Comune dove opera (che devono poi pagare imposte e tasse a quello stresso comune e hanno magari dipendenti che devono a loro volta pagare imposte e tasse al comune).
E dunque alla fine cosa succede? L’azienda di quel Comune si troverà a fatturare 20.000 euro che non avrebbe fatturato. Sono 20.000 euro in più di imponibile... Sul quale per altro si calcolerà il gettito delle tasse comunali.
Applica la stessa logica a molte delle spese di quel grande teatro in un anno: il risultato verosimile sarà un aumento del gettito comunale rispetto all’anno precedente. E il comune incasserà di più perché anche l'economia locale è cresciuta.
Proviamo ad applicare lo stesso ragionamento a livello nazionale: in aggregato l'economia nazionale che gravita attorno al settore performing arts verrebbe fortemente incentivata e di conseguenza aumenterebbe anche il gettito. Per questo può essere ipotizzabile, grazie al credito di imposta trasferibile, di innalzare del 100% il FUS. Perché l'anno successivo grazie all’indotto si potranno incassare più tasse grazie all'aumento del gettito, ferma restando invece la forte detassazione in partenza del settore dello spettacolo.
Si tratta per altro del cosiddeto moltiplicatore keynesiano, che dal rapporto Io sono cultura 2019 della Fondazione Symbola era già stato stimato in 1,8 per il sistema produttivo culturale e creativo in Italia: vale a dire che per ogni euro speso nel settore se ne attivano altri 1,8 in altri settori. Possiamo facilmente ipotizzare che grazie allo strumento dei crediti di imposta trasferibili questo moltiplicatore possa crescere sensibilmente.
Pura tecnicalità? O forse utopia?
A me sembra un modo possibile per tornare concretamente a pensare al teatro in termini di pluralismo e di sostenibilità.
Molto, certo, dipenderà dagli artisti, dalla loro capacità di restituire il teatro a quello che è sempre stato, come dicevano del resto con parole poetiche (al contempo chiare e sintetiche) gli stessi fondatori del Piccolo Teatro: «il luogo dove la comunità, adunandosi liberamente a contemplare e a rivivere, si rivela a se stessa».
Luogo dunque di dialettica sociale, ma non di uniformità sociale, esso non potrà che svolgere le proprie funzioni lavorando per differenziazioni. E proprio questo vi era nelle intenzioni originarie della Lettera programmatica per il Piccolo Teatro della città di Milano (pubblicata nel “Politecnico” di Vittorini nel febbraio 1947):
Crediamo sia tempo di sostituire il differenziato all’uniforme e lavorare in un primo tempo in profondità per potere, in un secondo momento, guadagnare in estensione: forse il gruppo dei nostri spettatori diventerà un nucleo vivo di aggregazioni più vaste: se non c’inganniamo, ogni civiltà si attua lungo un processo d’integrazione che accosta gruppo a gruppo, ed è tanto ricca quanto più è molteplice.
È un passo sorprendente, e anche molto chiaro se letto senza frapporre il filtro degli ultimi settant’anni.
Si tratta senz’altro di una rivendicazione della centralità della comunità cittadina come elemento interno agli stessi processi teatrali, da fondare sull’etica del piccolo gruppo e sulle sue potenzialità generative, che non possono che partire dal basso. Insomma, la comunità come molteplicità, il processo generativo di una communitas che si manifesta attraverso un poliedro di sensibilità artistiche; non certo l’idea di un teatro rappresentativo di una intera comunità, e in cui la collettività dovrebbe esprimersi anche attraverso rappresentanze politiche.
Si tratta infatti, soprattutto, di una forte rivendicazione dell’autonomia della sfera artistica, cui va lasciata la piena responsabilità (oltre che la piena libertà e possibilità) di governare e gestire i processi artistici entro una dinamica che “accosta gruppo a gruppo”, che procede per “differenziazioni”, aggregazioni, integrazioni successive, che, lavorando anzitutto in termini di intensità e profondità potranno progressivamente guadagnare terreno in estensione (e così guadagnare, nel momento di massima curvatura di questa molteplicità di esperienze, una dimensione comunitaria e pubblica).
Forse, se solo riuscissimo a toglierci gli occhiali deformanti delle politiche culturali, nelle buone intenzioni delle origini potremmo ancora trovare una guida affidabile ai problemi del nostro tempo.
Del resto, noi che ci occupiamo più o meno quotidianamente di queste faccende, sappiamo perfettamente quale strabordante domanda e necessità di teatro vi sia nelle nostre città, nei nostri borghi, per le nostre strade e piazze, tanto più nelle nostre case e cantine, luoghi di quarantena passata e forse futura; quale necessità vi sia dei mezzi del teatro, laddove si senta l’esigenza forte di costruire o ricostruire relazioni, in contesti di cura, nella formazione, nella politica e sempre più nel nostro vivere quotidiano.
Il fatto è che questa necessità di teatro spesso non viene riconosciuta e nominata come tale. E rimane (troppo spesso anche tra gli addetti ai lavori) la confusione tra teatro e spettacolo.
La sfida, se davvero un Paese come il nostro ci crede ancora, dovrebbe essere anche formare persone che, col teatro e con l’arte in tutte le sue forme, diventino cellule attive all’interno della società.
Questo soprattutto ci serve. Ci servono certo anche i produttori di spettacoli e gli artisti, ma meno di quel che ancora pensiamo. Di certo non ci servono gli artistoidi.
Stefano Locatelli, 12 maggio 2020