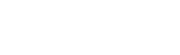Il cinema come serbatoio di immagini e caratteri, paesaggi e nostalgie, e non tanto di trame ovvero soggetti di facile presa sul pubblico. Una fonte di ispirazione, così come la letteratura ovvero l’attualità o la viva realtà della periferia torinese. Ecco allora che il celebre film di Giuseppe De Santis che, nell’Italia dell’immediato dopoguerra – siamo nel 1949 -, appassionò il pubblico alla tormentata vicenda della mondina “irregolare” Silvana Mangano disgraziatamente innamorata del furfante Vittorio Gassman fino al tragico epilogo, innesca narrazioni e riflessioni saldamente impiantate nel presente.
Certo i riferimenti alla pellicola di De Santis sono espliciti: la vicenda è ambientata nella cascina della Veneria, in provincia di Novara, dove venne effettivamente girato il film; un’enorme sagoma su cui è dipinto il volto della Mangano campeggia sul fondo del palcoscenico; le attrici indossano calze nere arrotolate all’altezza delle cosce come, appunto, le mondine. Il film costituisce, insomma, una sorta di «falsariga, sempre discreta, alla vicenda teatrale» (Oliviero Ponte di Pino, Un “riso amaro” per quattro ottimisti, su Il Manifesto, 3/06/1987), un paesaggio – fisico e sentimentale – per un racconto che nel presente trova argomenti ed emozioni. Sulla scena viene ritratto un «universo contemporaneo in cui la nostalgia delle mondine ormai scomparse si scontra con la realtà della violenza politica e della centrale nucleare di Trino e il tutto si interseca con citazioni della Crociata dei bambini come vago sogno di fuga verso impossibili Terre Promesse» (Renato Palazzi, Due coppie in cerca di radici contadine, su Il Corriere delle Sera, 30/05/1987). Il cinema neorealista di De Santis dialoga, dunque, con l’attualità e con la letteratura – Marcel Schwob, l’autore francese di origine ebraiche che, alla fine del XIX secolo, narrò il viaggio per liberare Gerusalemme compiuto sei secoli prima da un manipolo di fanciulli, infelicemente convinti di poter essere artefici di un futuro migliore.
Ma di cosa parlava, esattamente, Riso amaro? Nel programma di sala, la compagnia sottolineava come l’avvento delle macchine avesse profondamente modificato il paesaggio del vercellese, un tempo, per lo meno durante i mesi della raccolta del riso, popolato dalle mondine, che abitavano le cascine della zona, poi abbandonate. Questo il destino anche della Veneria, dove si sono rifugiate due coppie di cui il pubblico può udire le conversazioni avvenute in sei sere consecutive. Personaggi che, ogni sera, si addormentano ma il loro «non è un sonno immemore», bensì «una pausa, il riposo, l’interruzione benefica dell’affaccendarsi, la sospensione della ricerca del come, per abbandonarsi e concedersi il tempo di chiedersi perché». Perché uno dei giovani deve nascondersi mentre l’altro pare non riesca ad affrancarsi dalla razionalità? Perché i sentimenti che le due giovani donne provano per i rispettivi compagni all’improvviso vacillano e, come nelle Affinità elettive – e d’altronde Riso amaro segue proprio Elementi di struttura del sentimento e, come quello, a Goethe esplicitamente guarda – si assiste alla dissoluzione e poi alla ricomposizione delle due coppie? Interrogativi per i quali non esistono, ovviamente, risposte anche perché, come evidenziava Renato Palazzi nell’articolo succitato, lo spettacolo mirava «a raccontare non tanto una storia quanto una trasparente partitura di stati d’animo»; non solo, Riso amaro, annotava Ugo Volli (Torna ‘Riso amaro’ e c’è il nucleare, in Repubblica, 29/05/1987), «vuol essere simbolico nell’assieme ma naturalistico nei particolari». In sostanza, descrivere lo spaesamento, la nostalgia – senza rimpianto però – di un passato apparentemente più “puro”, la speranza – magari un po’ utopica – in un avvenire più soddisfacente di quattro quasi trentenni: tutti stati d’animo che diventano esemplari di una generazione.
Un obiettivo raggiunto non tanto con elaborate speculazioni – non a caso Volli parlava di «ciangottio continuo, molto quotidiano e spesso vicino al soliloquio» – quanto con la creazione di uno spazio scenico che appare quale «luogo deputato dell’azione e dell’illusione, un’immagine di vita possibile» (Maria Grazia Gregori, Stasera si recita la favola, in L’Unità, 28/05/1987). Un allestimento inventivo e flessibile, separato dalla platea da un sipario – cucito a mano da Fabbris e Zamboni – fatto di sacchi di juta per il riso e abitato da un praticabile di tubi e assi di legno che le due coppie smontavano e ricostruivano più volte nel corso dello spettacolo, dando così vita a «un’azione teatrale che si fa sempre più nevrotica, carica di tensione» (Maria Grazia Gregori, cit.). Palcoscenico sul quale, nel finale, rimanevano sei pentole a pressione appoggiate ciascuna su un fornelletto da campeggio e che, lentamente, iniziavano a fischiare, inedita colonna sonora alla solitudine dei quattro personaggi, ognuno impegnato a cucinare per conto proprio. Non si trattava, tuttavia, di un invito a uno sterile solipsismo, bensì la necessaria “rimasticatura” di quanto vissuto e provato in quei sei giorni e la progettazione di un nuovo inizio, all’insegna, probabilmente, di un «recupero della tenerezza dei corpi e degli affetti» (Oliviero Ponte di Pino, cit.). E di “tenerezza” parlava anche Renato Palazzi, cogliendo una parola – e un sentimento – chiave per Laboratorio Teatro Settimo: non tanto una superficiale commozione, quanto una profonda pietas nei confronti degli altri ma, in primo luogo, verso se stessi.
RISO AMARO
di Curino, Diana, Fabbris, Tarasco, Vacis, Zamboni.
Regia di Gabriele Vacis.
Scrittura testi di Laura Curino.
Allestimenti scenografici di Lucio Diana e Adriana Zamboni.
Costumi di Mariella Fabbris.
Luci e suono di Roberto Tarasco.
Con Lucilla Giagnoni, Rossella Testa (poi Paola Nervi), Marco Paolini, Roberto Tarasco.
Produzione: Laboratorio Teatro Settimo, ISTMO; Centro di Ricerca per il teatro di Milano.
Debutto: Milano, Teatro dell’Arte, maggio 1987.