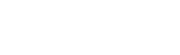Condividiamo l'intervento di Gabriele Vacis e Alberto Vittone intitolato "Ripensare al teatro al tempo dei Covid" all'interno del libro "Le parole della crisi le politiche dopo le pandemia - Guida non emergienziale al postCovid19" (Editoriale Scientifica)
Lo scorso 11 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Covid-19 una pandemia. Molti paesi hanno conseguentemente adottato o inasprito le misure di contenimento della mobilità e la sospensione delle attività produttive. Inevitabilmente, la crisi ha coinvolto la sfera economica, quella sociale, il mondo culturale e l’ambito politico-istituzionale, in alcuni casi esacerbando tendenze che erano presenti in nuce nella trama delle relazioni intersoggettive, altre volte lacerando le aspettative, i valori e le percezioni sui quali ciascuno di noi, e la comunità nel suo complesso, definisce e articola la propria esistenza.
Il CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, come associazione di studenti, dottorandi e giovani ricercatori, con diversi background, propone un volume che analizza, in chiave transdisciplinare, la pluralità dei possibili effetti dell’emergenza in corso e indica alcune linee direttrici per immaginare la sua gestione nei prossimi mesi, mediante un approccio specifico e originale: il libro è infatti il frutto della collaborazione tra giovani studiose e studiosi e figure autorevoli del dibattito culturale italiano e internazionale.
RIPENSARE AL TEATRO AL TEMPO DEL COVID-19
GABRIELE VACIS − ALBERTO VITTONE
Sarà perché è la più sacra e antica forma di “assembramento” ma il teatro sembra una delle vittime sacrificali del coronavirus. Anche nella “fase 2”, la ripresa delle attività in questo settore è stata l’ultima, e sarà sottoposta a complicate condizioni: ingressi scaglionati, prenotazioni on-line, posti preassegnati... È strano, perché i teatri sono luoghi della meditazione civile: sarebbe molto utile tenerli aperti in tempi come questi. Del resto, i palchetti degli antichi teatri all’italiana sono un esempio perfetto di “distanziazione sanitaria” che evita la “distanziazione sociale”. Comunque sia, l’epidemia costringe a rifuggire la prossimità e il contatto fisico, privando il teatro di due componenti fondanti la sua stessa natura. Ma il problema non è se Romeo potrà tornare a baciare Giulietta o se una lastra di plexiglas dovrà proteggere Creonte dalle maledizioni di Antigone. Il pur indispensabile distanziamento sanitario sembra minare il cuore stesso del rito teatrale: l’interazione tra gli attori e tra gli attori e gli spettatori, ma anche tra spettatore e spettatore. Ha ragione quindi Marco De Marinis quando scrive che, nell’emergenza sanitaria, “il teatro dovrà accettare per un periodo di non essere interamente sé stesso: cioè dall'incontro reale ravvicinato di attori e spettatori”. Si spera, ovviamente, che queste norme sanitarie durino il meno possibile, ma proprio questo blackout, questo temporaneo annullamento di sé, potrebbe indurre il mondo del teatro a fare di necessità virtù. Chissà che non sia l’occasione buona per ripensarsi, per ridefinire la propria specificità di teatro. Da più parti si sente dire che la “fase 2” potrebbe essere il momento per far tesoro delle consapevolezze acquisite allo scoppiare della crisi, e caricarsi di proposte originali per una nuova “normalità”. Proviamo a capire quali sono queste proposte originali, da quali forze sono sostenute e da quali ostacolate.
Partiamo dall’aspetto che la pandemia ha evidenziato in maniera più drammatica: la fragilità economica del settore teatrale. Il lavoro culturale nel suo complesso è spesso precario. E se nei ruoli gestionali, amministrativi e tecnici “la società” pare ancora riconoscere delle professionalità, con grande difficoltà dietro l’artista viene riconosciuta la figura di un lavoratore, in primis dagli organi di potere. Nel corso delle fasi 1 e 2, attori, registi e artisti in genere hanno manifestato nelle piazze, scritto proclami e lettere aperte a governo, direttori dei teatri e delle grandi fondazioni. Rivendicavano voce in capitolo sulle politiche economiche
dell’emergenza. Tuttavia, pur essendo il più duramente colpito dal lock-down, il settore dello spettacolo è stato “l’ultimo a essere considerato nel pacchetto di aiuti”. Il Decreto Rilancio del 19 maggio ha stanziato 5 miliardi di euro per il Mibact, 4 per il turismo e uno per cultura e spettacolo (a fronte di una perdita calcolata di un miliardo e mezzo). Se, nella fase 1, il mondo del teatro è stato paralizzato dall’incertezza sul futuro (si parlava di una riapertura nel gennaio 2021), la fase 2 non ha portato sollievo. Mentre ripartivano diversi settori produttivi, l’assenza di indicazioni e di prospettive ha confermato la scarsa (se non nulla) considerazione di cui le istituzioni teatrali godono quando si parli di economia, sebbene forniscano lavoro a più di centomila persone, garantendo anche un indotto tutt’altro che trascurabile, dai ristoranti agli alberghi e al supporto al turismo in generale. A tutto ciò andrebbe poi aggiunto il variegato ausilio offerto alla formazione e al “terzo settore”: sono sempre di più gli artisti che lavorano nelle scuole, negli ospedali, nelle periferie degradate con interventi di tipo sociale e di cura della persona. Per ora limitiamoci a considerare come l’intervento tardivo della politica nei confronti dei “lavoratori dello spettacolo” abbia confermato la scarsa considerazione rispetto ad altre attività produttive, anche a fronte di dichiarazioni spesso altisonanti del tipo: la cultura è la spina dorsale del nostro paese! Oppure: il Ministero della Cultura è il più importante ministero economico del governo! Ma queste considerazioni riguardano l’atteggiamento del mondo esterno nei confronti del “settore” e viceversa. Adesso vediamo quello che la pandemia ha prodotto all’interno del settore. Fin dai primi giorni di isolamento si è sviluppato un dibattito che non si vedeva da anni. Zoom e le altre piattaforme digitali sono state teatro di confronti che hanno fatto emergere soprattutto la sperequazione economica interna all’ambiente teatrale. Mali antichi che forse sono corresponsabili anche della scarsa considerazione esterna di cui gode il settore. E qui cominciamo a restringere la nostra analisi al teatro e alle sue strutture. Nel corso della clausura è come se una generazione di giovani artisti avesse preso coscienza di due fatti. Primo: i funzionari amministrativi ed organizzativi delle istituzioni sono garantiti da contratti a tempo indeterminato e gli artisti no. Secondo: la sproporzione tra le paghe di artisti che lavorano spesso fianco a fianco è grande e ingiustificata di fronte al “mercato”. Contraddizioni evidenti da tempo, ma che solo in questo periodo si sono affacciate alla consapevolezza di attori, scrittori, registi... Perché? Per spiegarlo ci vogliono i poeti. Mariangela Gualtieri, che è anche un’attrice, l’ha detto appena partito il lockdown: Questo ti voglio dire / ci dovevamo fermare. / Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti / ch’era troppo furioso / il nostro fare. Stare dentro le cose. / Tutti fuori di noi. / Agitare ogni ora – farla fruttare. / Ci dovevamo fermare / e non ci riuscivamo. / Andava fatto insieme. / Rallentare la corsa...
Quella che è venuta fuori è una frattura tutta interna al teatro tra “manager” che negli ultimi decenni hanno conquistato posizioni di potere incontrastato e artisti sempre più alla loro mercé. Quando ci si rende conto delle differenze di trattamento economico tra artisti che lavorano fianco a fianco non giustificate dal mercato, prima di tutto bisogna dire che il mercato, nel teatro, quasi non esiste. È quasi tutto pubblico. Certo, ci sono artisti che “chiamano” e hanno tutto il diritto a farsi pagare in proporzione a quello che incassano. Spesso sono comici che fanno sano intrattenimento. E questi sarebbero, e spesso sono, perfettamente in grado di reggersi in un sistema di economia privata. Poi c’è tutto un mondo che, non reggendosi con gli incassi, è sorretto dal denaro pubblico. Ma c’è una grande confusione tra le ragioni che fondano il teatro privato e, soprattutto, quello pubblico. Da qui nascono le inspiegabili sperequazioni tra le retribuzioni nel teatro sovvenzionato. Il problema è che le ragioni del teatro pubblico, fondate dal sodalizio tra Paolo Grassi e Giorgio Strehler, sembrano ormai dimenticate. Anche perché non sono più nutrite da studiosi come Mario Apollonio, Gerardo Guerrieri, Gianrenzo Morteo. Naturalmente, oggi come allora, ci sono cervelli che elaborano analisi e idee straordinarie, che tuttavia giacciono inascoltate ed isolate nei rispettivi ambienti. Il problema, cioè, è la frattura tra arte, organizzazione e pen- siero. Frattura operata in nome di un efficientismo, più che “manageriale”, algoritmico, ch’era troppo furioso, come dice la Gualtieri. Chi è in grado di dire, oggi, perché si finanziano “teatri nazionali” che si vantano di essere “spettacolifici”? Perché i soldi dei contribuenti pagano l’intrattenimento degli spettatori di certi teatri (quelli pubblici) e di altri no (quelli privati)? Se al tempo di Grassi e Strehler erano chiare le differenze tra teatro pubblico e teatro privato, oggi quali sono? Queste sono le domande che pone il “reparto economia” del settore, dopo lunghe di- scussioni su Zoom nel tempo della pandemia. Domande semplificate nella presa d’atto dei due fatti: apparati garantiti artisti no e sperequazione tra gli artisti. Se si vuole davvero rispondere a queste domande, però, bisogna svincolarsi dal reparto economia. Bisogna entrare in altri territori, molto più complessi. Poi rispondere alle questioni economiche sarà più facile.
I teatri sono stati tra i primi luoghi pubblici a chiudere: il 24 febbraio nel Nord Italia, i primi di marzo nel resto della penisola. Non è la prima volta che il mondo del teatro si ferma causa epidemia. Già Shakespeare si era ritrovato a scrivere alcuni dei suoi capolavori in quarantena, come conseguenza della peste che colpì Londra tra XVI e XVII secolo. All’epoca dev’essere stato davvero difficile comunicare, chiusi in casa. Invece adesso abbiamo Zoom, Skype, Google Meet e tutti gli altri. Veramente queste piattaforme erano disponibili da anni. Adesso siamo stati costretti ad imparare ad usarle. Il mondo del teatro, come tutti gli altri mondi, chiuso in casa, ha dovuto per forza fare i conti con i traguardi raggiunti dalle tecnologie della comunicazione. Così abbiamo capito co- sa significasse davvero quello smart working che sembrava una favola avveniristica. I settori che hanno a che fare con il riciclo, con la moda, con l’economia circolare, il privato in genere, magari lo sapevano già, ma anche lì si usava poco. Quelli però che hanno più a che fare con il corpo e con la concretezza del mangiare o del dormire non lo usavano proprio lo smart working. Invece, nel lockdown, perfino la scuola ha dovuto farci i conti. È strano, perché i soggetti della scuola, gli studenti, sono nativi digitali. Loro cos’era Zoom, ma soprattutto TikTok o Instagram, lo sa- pevano benissimo: li usano da quando sono nati. E qui sta il nodo che vogliamo affrontare. Osserviamo quello che ha tutta l’aria di un para- dosso: i sindacati degli insegnanti, nella Fase 3, rivendicano la scuola “in presenza”. Chi andava alle elementari negli anni Sessanta o Settanta ricorda certamente che la maestra faceva l’appello tutte le mattine. E gli alunni dovevano rispondere: presente! Non era un’azione formale. La maestra o il maestro avevano la competenza e la sensibilità per capire se i ragazzi che avevano di fronte erano veramente presenti o se avevano la testa chissà dove. Chi fa teatro sa che essere presenti a sé stessi, agli altri, al tempo e allo spazio è, forse, la cosa più importante che la scuola dovrebbe insegnare. Ce lo hanno insegnato i maestri del teatro del Novecento, che hanno lavorato principalmente su questo: essere presenti in scena. I dervisci rotanti, prima di cominciare le loro danze, si augurano reciprocamente: sii presente a te stesso. Il teatro è sempre stato ed è sempre più vicino al rapporto pedagogico che allo spettacolo. Se è questo che rivendicano i sindacati degli insegnanti bisognerebbe associarsi senza riserve. Forse, però, allora, bisognerebbe istituire corsi appositi di “Presenza”. E forse attori e registi sarebbero i più titolati a tenere questi corsi. E, forse, chissà, col tempo, la smetterebbero di augurarsi la volgarità che si augurano adesso entrando in scena e comincerebbero ad augurarsi anche loro: sii presente a te stesso. Allora, forse, il mondo politico ed economico prenderebbe a guardarli con più attenzione.
Se l’uso abituale delle piattaforme digitali ha ricordato l’importanza della “presenza” nella scuola, nel mondo del teatro ha prodotto un altro effetto: ha chiarito come, oggi, la riproduzione sia sempre più vicina alla presenza. Il teatro avviene in tempo reale. Chi parla e chi ascolta sono presenti nello stesso tempo e nello stesso spazio. La presenza è impor- tante perché chi parla può ascoltare chi lo ascolta. Chi agisce può vedere chi lo guarda. Il teatro è contemporaneamente guardare ed essere guar- dati, e questo vale sia per l’attore che per lo spettatore: nei teatri all’italiana anche gli spettatori stanno nei palchetti. Per questo abbiamo detto che il teatro assomiglia sempre più al rapporto pedagogico. A scuola il maestro vede gli allievi che lo guardano, può ascoltarli mentre lo ascoltano. Quello che dirà e come lo dirà, quello che farà e come lo farà sarà fortemente influenzato dallo sguardo e dall’ascolto degli allievi. Gli allievi non gli sono indifferenti. Al contrario: determinano la sua azione. Come a teatro. La scuola e il teatro possono praticare la comunicazione diretta, senza mediazioni né scarti. In qualunque forma di co- municazione mediata da strumenti tecnologici una tale unità percettiva non è possibile. Gli attori che guardo sullo schermo di una sala cinema- tografica o sul mio iPad su Netflix non mi vedono, nel momento in cui io li vedo e li ascolto chissà dove sono. Se guardo Ombre rosse sono già tutti morti. Non tengono conto di me spettatore, non possono. Gli sono indifferente. Per questo l’esperienza del teatro è completamente diversa dall’esperienza del cinema. Estremizziamo: dice il vocabolario che l’esperienza è una conoscenza acquisita mediante il contatto con un determinato settore della realtà. Il cinema non è reale, nel cinema non c’è “contatto”, quindi non è un’esperienza. Il teatro sì. D’accordo, è un ragionamento un po’ stiracchiato. Ma serve a dire che nell’epoca del cinema questa differenza era sufficiente a giustificare l’esistenza stessa del teatro. Ed è una differenza che non potrà mai essere colmata. Neanche quando avremo strumenti che ci permetteranno di toccare e guidare gli attori che guarderemo su qualunque “supporto” digitale o ologramma.
Perché l’essenza del teatro è lo sguardo ricambiato tra persone reali, che si influenzano a vicenda. È il riconoscersi nel volto concreto dell’altro. E la reazione dell’altro non è mai prevedibile. Il teatro è reciprocità, riconoscimento dell’alterità nell’uguaglianza. Non è lo sguardo di Narciso verso sé stesso, è lo sguardo aperto sull’inconosciuto. È presenza per la relazione, ed è dalla relazione che nasce la comprensione dell’altro, e dalla comprensione le comunità. È un territorio in cui etica ed estetica possono incontrarsi più facilmente che altrove.
Tuttavia, dicevamo che la pandemia ci ha insegnato ad usare mezzi che avvicinano la riproduzione alla presenza. Attenzione: avvicinano, non equiparano. Cioè: pur non sostituendo la presenza Skype o Zoom attivano un livello di dissociazione decisamente minore rispetto a quella del cinema. Insomma, le possibilità offerte dalle dirette Instagram o dalle call di Google Meet rimettono in discussione l’esperienza teatrale. Se i maestri del Novecento, da Stanislavskij a Copeau, da Brook a Grotowski al Living Theatre, ci hanno insegnato perché valeva la pena continuare a fare teatro nel tempo del cinema, è ora di cominciare a chiederci seriamente perché vale la pena di continuare a fare teatro nel tempo di Netflix, di Zoom e di tutti gli altri.
La fase 1 del lockdown è stata tutta un fiorire di spettacoli offerti in rete, di dirette streaming, letture in video. Esperimenti che hanno inevitabilmente acceso un dibattito sulla liceità di chiamare teatro una tale produzione di forme. Era un dibattito ingenuo, ma, insomma, non se ne parlava da tanto, quindi: meno male che c’è stato, è il contributo che l’emergenza sanitaria potrebbe aver consegnato alla riflessione sulle sorti del teatro. Sono infatti bastate poche settimane di lockdown e distanza sociale, perché si confermasse l’idea che il teatro ha senso solo nel momento in cui è un’esperienza innanzitutto fisica. Non stupiscono quindi le reazioni critiche sorte alla boutade del ministro che proponeva la creazione di un “Netflix della cultura”. Chissà a cosa pensava. Ad una RAI5 in rete a 11,90 euro al mese? Tuttavia, l’associazione tra piattaforma di streaming e teatro, può essere uno spunto interessante proprio per capire perché vale la pena continuare a fare teatro nel tempo di Netflix. Viviamo in un tempo di proliferazione ipertrofica di forme, e in una realtà in cui le possibilità di “riproduzione” della realtà stessa sono tante e dinamiche. Netflix, Sky, Amazon offrono un accesso illimitato a forme drammaturgiche sempre più sofisticate; contemporaneamente, YouTube e Pinterest producono a getto continuo forme tout court. Tale processo è stato incrementato dalla quarantena, e ha coinvolto un numero sempre maggiore di persone nel consumo ma anche nella creazione di contenuti. Ma attenzione a come usiamo questa parola: contenuti. Un tempo voleva dire senso, significato pesante di un’azione. La forma era opposta al contenuto. Oppure il contenuto era forma e la forma conte- nuto. Oggi i contenuti sono semplicemente quello che sta dentro ad una piattaforma web. A causa del coronavirus, il teatro per necessità ha dovuto confrontarsi con tale mondo, una soluzione accettata e accettabile solo in quanto temporanea, e in quanto accompagnata dalla speranza di un’imminente ripresa delle attività. Ma questo desiderio di ritorno alla propria dimensione sembra sia sintomatico della presa di coscienza che, nel mondo delle nuove tecnologie, il teatro non può reggere il confronto con la produzione sempre più spinta di forme. Nel tempo del cinema era sufficiente la presenza viva di attori in una scena che rappresentava la realtà, oggi non sembra più sufficiente, se non in termini di “documento” di un’altra epoca. Ma di questo parleremo dopo. Adesso dobbiamo evidenziare come due o più attori che dialogano protetti dalla “quarta parete” assomigliano molto a due o più attori che si muovono in uno schermo. Anche perché l’accessibilità di questi schermi è aumentata e continua ad aumentare esponenzialmente. I programmi di montaggio come Final Cut o Premiere, fino a quelli che usano i ragazzini per Tik-Tok, offrono una confidenza con il cinema che costringe il teatro a evidenziare ulteriormente i propri caratteri. Per tutto il Novecento i maestri del teatro hanno lavorato all’abbattimento della quarta parete. Oggi diventa ancora più necessario portare in luce l’aspetto esperienziale del teatro. Ormai, se l’attore che mi parla dal palcoscenico di un teatro non ascolta lo spettatore, se la platea è avvolta nel buio e il pubblico non può essere guardato dall’attore, è inutile andare a teatro: funziona meglio Netflix. Due personaggi che dialogano alla luce mentre io che ascolto sto al buio – cioè in un altro spazio – è molto più comodo guardarli e ascoltarli su un iPad che in un teatro. Questo perché un teatro di forme è meno efficace di una piattaforma streaming o di YouTube, che docu- mentano forme di realtà a getto continuo. Ed è proprio per questo che il teatro continua ad essere necessario. È proprio per questo che, nono- stante tutti i proclami funebri di tanti attori e registi e scrittori, il teatro non muore. Non morirà mai perché è reale. Perché, come racconta Cormac McCarthy nel suo romanzo La strada, dopo la catastrofe, quando non esisteranno più macchine per comunicare, due o tre esseri umani si incontreranno, si guarderanno e si riconosceranno l’uno nello sguardo dell’altro. E quello è il teatro. Riconoscersi nello sguardo dell’altro. Quindi è necessario proprio nella mutazione continua che stiamo vivendo, in quanto esso è l’unico mezzo di comunicazione non mediato, e che perciò riesce a comprendere la molteplicità delle azioni di guardare ed essere guardati, di ascoltare ed essere ascoltati. Per questo un teatro di attori che non ascoltano chi li ascolta e non vedono chi li guarda troverà sempre meno ragioni di fronte alle tecnologie. Al contrario, l’evento teatrale si arricchirà di senso con attori che rimodulino le proprie compe- tenze al servizio dell’ascolto. Ci sono molte resistenze a questo riguardo. Molti attori, registi, scrittori si sentono minacciati dalle tecnologie. Temono di dover rinunciare alle proprie competenze, alla propria sapienza. Niente di più sbagliato. Ci chiedevamo all’inizio chi coltiva le idee esplose con evidenza nel lockdown e chi mette i bastoni tra le ruote. Ecco, la paura della mutazione ostacola l’innovazione. E le grandi istituzioni spesso si rinchiudono nella difesa ad oltranza delle forme teatrali. Ma se c’è qualcosa che ha chiarito inconfutabilmente questo lockdown è la necessità del contatto tra le persone. Avremo sempre più bisogno di teatro, cioè di specialisti della relazione, dell’interazione. Certo si tratterà di imparare, oltre che a preparare spettacoli, a prepararsi allo scambio, all’incontro con le persone, che saranno sempre meno spettatori e sempre più “testimoni” di esperienze reali, o addirittura “attuanti”, come diceva Grotowski. Avremo sempre più bisogno di attori a cui il pubblico non sia indifferente, e che siano sempre più disposti a farsi condizionare dalla relazione. A proposito di Grotowski che parlava di “arte come vei- colo”: veicolo verso l’altro, prima di tutto. E poi veicolo verso dimensio- ni spirituali, che Carmelo Bene sintetizzava con la battuta “Io non parlo, io sono parlato”. Chiaro che non si riferivano alla creazione di forme, ma di interazione. Perché l’arte, la bellezza, il teatro sono stati per troppo tempo ostaggio delle forme, e ora devono liberarsi dalle catene formali attraverso la relazione. C’è più bellezza negli occhi di due persone che vedono quello che guardano, c’è più bellezza nelle orecchie di due per- sone che ascoltano quello che sentono che in mille forme prodotte da Pinterest.
Insomma, constatata la scarsa considerazione di cui gode il teatro nella società contemporanea, si possono, per innalzarla, giocare carte che valgono, e valgono parecchio: essere presenti a sé stessi, agli altri, al tempo e allo spazio, per esempio, quanto sarebbe necessario per com- prendere quando sei vicino e quando devi “distanziarti” dall’altro? Yuval Noah Harari dice che dopo la pandemia abbiamo due strade . La prima è consolidare autoritariamente le limitazioni della libertà che abbiamo scelto nella necessità sanitaria. La seconda è la consapevolezza di ripristinare e possibilmente ampliare le libertà e i diritti di movimento. Sono atteggiamenti che riguardano la vita collettiva, la grande scommessa del futuro che è la convivenza, la democrazia e le sue nuove espressioni. Il teatro non può tirarsi indietro, deve dare il contributo che ha maturato in secoli, millenni di conoscenza. Da quando il teatro di Epidauro era un reparto del tempio di Asclepio, il più grande ospedale dell’antichità. Da quando San Francesco, come dice Antonio Attisani, praticava una teatralità estranea alla produzione di forme, ma che si manifestava come “un’attività filosofica e cognitiva, come gioco e insegnamento, dove non contavano le forme intese come prodotto e modello, come “immagine”, ma un’azione strutturata, un processo destinato a trasformare il corpo-mente di attori e spettatori” . Il fatto che il primo mi- nistro abbia parlato degli artisti come persone che fanno divertire e ap- passionare non è certo sintomo di una volontaria sferzata al mondo dello spettacolo; piuttosto, come ha scritto Franco Perrelli in un post su Fa- cebook: “la sua espressione dimostra quanto remoto e vago il mondo dell'arte resti per le torreggianti burocrazie, gli apparati di governo, le “cose che contano", quanto sia percepito come effimero e lieve. A mio modesto parere, se chiunque avesse qualsiasi responsabilità di governo invertisse questo punto di vista, immediatamente, coglierebbe un miglioramento qualitativo della sua azione e della sua comunicazione”.
Forse bisognerebbe smetterla di offendersi invocando rispetto e attenzione per cominciare a mettere sul piatto quei carichi pesanti di contenuto culturale, sociale e anche politico che abbiamo cominciato ad elencare. Quando fu istituzionalizzato, nel Secondo dopoguerra, il teatro pubblico era considerato alla stregua della metropolitana e dell’acqua corrente, in altre parole, un servizio pubblico inclusivo. Ciò che, come allora, ancora oggi giustifica il fatto che si paghino le tasse anche per il teatro, è che lì accade la contemporaneità, lì posso ascoltare chi mi ascolta, e guardare chi mi guarda. E questo è servizio sociale.
Per concludere, quindi, useremo le parole del direttore della maggiore istituzione teatrale italiana: “riscoprendo la sua componente relazionale, il teatro può – dice Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano – diventare lo strumento per riconquistare la vicinanza persa a causa della pandemia”. Speriamo voglia dire che la pratica teatrale dovrà, anche e soprattutto nelle grandi istituzioni, affiancare la produzione di forme con creazione di momenti di integrazione sociale e interculturale. Essa, infatti, resta una delle sempre più rare occasioni di comunicazione diretta, in un mondo in cui la comunicazione mediata ci subissa continuamente di forme. Dal momento che, come ribadito più volte, in teatro chi parla può ascoltare chi ascolta, è questo ciò per cui si deve la- vorare, al fine di formare un attore – per usare un termine di Grotowski – aware e autore della propria presenza in scena. E per quanto, giustamente, tutto questo sembri non avere a che fare con i personaggi, la psicologia o la messinscena, tuttavia “allo stesso tempo può essere una tecnica utile per ogni idea di teatro”. Perché qui si vuole rifuggire ogni contrapposizione tra la realizzazione di forme e la creazione di relazioni: non è una questione di alternative. Il teatro, per così dire, tradizionale può e deve continuare a vivere, ma accettando la sua funzione museale.
Prima abbiamo chiamato questo teatro “documento” di epoche. Onde evitare ogni fraintendimento, è importante grattar via dalla parola museo tutte quelle incrostazioni semantiche afferenti al campo lessicale dell’inutilità, decrepitezza, noia. Andare al museo è bello, i musei hanno tanto da insegnare e tanto possono emozionare. In quest’ottica, un teatro museo svolge un ruolo decisivo, ad esempio, nella costruzione dell’identità. Ma non è l’unica realtà possibile. Ci sono altri modi di fare teatro, modi in cui conta il processo della pratica teatrale, più che lo spettacolo finale. E c’è bisogno che le grandi istituzioni teatrali si scrollino di dosso la paura di questi discorsi e di tali prospettive. Così da comprendere la molteplicità di ruoli che il teatro deve tornare ad avere: dal “museo” all’inclusione. Per dirlo con Wendy Steiner: “anche se il destino della bellezza è stato legato a lungo alla forma, la chiave del suo futuro sarà l’interazione” . La pandemia ci ha violentemente riportato con i piedi per terra dopo un lungo periodo di sospensione della realtà. Ci ha fatto vedere, in trasparenza, in negativo, per paradosso, come potrebbe essere migliore il mondo. Ha sbiadito definitivamente concetti come forma e contenuto. Ricomposto etica ed estetica. Non perdiamo l’occasione.