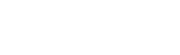Non tanto – o, meglio, non soltanto – uno spettacolo pensato già “concluso” e pronto per repliche e tournée, quanto un primo approccio, la tappa d’esordio di un percorso progettuale complesso denominato Dura madre mediterranea. Vacis, Curino e Tarasco, ideatori del progetto, nel testo di presentazione, definirono Nel tempo tra le guerre «un prologo a due spettacoli ispirati ai mondi di G.G. Marquez e F.S. Fitzgerald. […] È la costruzione di un universo all’interno del quale far abitare i due prossimi lavori». Messinscene, queste ultime, di cui parleremo in seguito, svelando anche come la contingenza costrinse a una modifica – “sperimentale” e proficua – del progetto, intanto è interessante sottolineare la peculiare definizione di “studio” attribuita a questo “prologo”, poiché rivelatrice di una modalità di ricerca artistica orgogliosamente anti-economica. Così, infatti, scrivevano Vacis, Curino e Tarasco: «nel nostro percorso produttivo la presentazione di studi costituisce una prima definizione d’ambiente. Durante la fase ideativa è importante l’incontro con il pubblico per dare all’allestimento il necessario tempo di sedimentazione e consentire una momentanea emersione dall’apnea della composizione. Gli studi sono quindi un tempo sospeso in cui il gruppo prende forma e autonomia rispetto alle caratteristiche dei precedenti spettacoli, e sono funzionali a una metodologia progettuale che tiene conto del tempo e non prefigura utopicamente “il” risultato ma innesta processi che muovono verso “un” risultato che ancora non si conosce».
Il respiro che attraversava Nel tempo tra le guerre era, nondimeno, profondo e vivificante: ispirato a Garcia Marquez – ma anche a Clarice Lispector, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges – lo spettacolo narrava la vana attesa del proprio padre da parte dei diciassette figli concepiti dal Colonnello, con donne diverse, nel corso delle sue infinite campagne militari e inviati a vivere nella stessa grande casa, dove sopravvivono, fra l’altro, riparando radio. E, proprio ascoltando un radiogiornale, i fratelli – i cui nomi iniziano ciascuno con una lettera diversa, in rigoroso ordine alfabetico – vengono a sapere che il Colonnello si è arreso e, dunque, farà ritorno a casa: i giorni passano e l’entusiasmo lentamente si spegne fino a quel lunedì 15 giugno in cui giunge la notizia che l’inarrestabile militare si è rimesso in marcia verso il Nord, verso nuovi campi di battaglia, e da quel momento per i fratelli «le cose si sono messe ad andare più lentamente come il cuore di quelli che sono stati trapiantati». L’attesa è, dunque, il contenuto di uno spettacolo che, tuttavia, non è pervaso da mesta nostalgia, bensì immerso in un’atmosfera immaginifica e ognora cangiante, in cui si combinano la «”naturalezza” della recitazione e sospensione magica e onirica della realtà fisica» (Stefano Casi, in Così recitano gli oggetti, su L’Unità del 22/07/1988).
Allestito in spazi rigorosamente all’aperto – il debutto avvenne nell’aia della grande villa di San Mauro Pascoli nell’ambito del Festival di Santarcangelo, coproduttore dello spettacolo insieme ad Asti Teatro – il lavoro prevedeva il susseguirsi di narrazioni e immagini, «con forme sempre nuove di illuminazione, di coreografia, di sistemazione dello spazio» (Ugo Volli, in Continua il festival di Santarcangelo, su Repubblica, 14/07/1988). Una varietà di situazioni e umori, di linguaggi e colori bene sintetizzata da Roberto Canziani: «una composizione sicuramente appartenuta a Caravaggio si lascia sciogliere dall’allegria beffarda di una marionetta catalana, alla voce di un giovane sergente di nome Frank Sinatra rispondono l’eroica prestanza dell’inno nazionale russo e decine di bandierine da segnalazione marittima, dissipate subito dal tempo del calcio balilla e del cinema decima musa» (Uno spazio, un progetto, su Il Piccolo, 25/07/1988). E, ancora, le trapunte colorate che piovono dall’alto e di cui gli attori fanno tappeti e rassicuranti capanne. Un accumulo di materiale che, dichiarò allora Gabriele Vacis, «verrà poi diluito e sviluppato nello spettacolo vero e proprio. Non esiste copione, ma una bozza che prende corpo via via perché i nostri attori non lavorano sulla finzione ma sulla realtà e godono di un’autonomia vastissima» (in Donata Gianeri, Nel tempo tra le guerre ne succedono di cose, su Stampa Sera, 18/07/1988). Una modalità di lavoro che, non a caso, venne fatta discendere dalla pratica teatrale elaborata in Francia da Ariane Mnouchkine – “maestro” riconosciuto dal Laboratorio Teatro Settimo, che la ospitò proprio a Settimo Torinese – ma che, come sottolineò Valeria Ottolenghi, veniva tradotta in «forme più immediate» (in Tra le guerre con Fiat Teatro Settimo, su La Gazzetta di Parma, 23/07/1988). Un’immediatezza frutto di una pratica flessibile e cangiante, allenata a modificare e inventare in base al particolare spazio in cui lo spettacolo veniva allestito, così come alle reazioni del pubblico e al “clima” che le irripetibili condizioni di ogni replica determinavano. Un’immediatezza frutto dell’irrinunciabile esigenza, da parte di teatro Settimo, di essere nella realtà.
Laura Bevione
NEL TEMPO TRA LE GUERRE
progetto, direzione, composizione di Gabriele Vacis, Laura Curino, Roberto Tarasco
Immagini, allestimenti di Lucio Diana, Mariella Fabbris, Adriana Zamboni.
Con Laura Curino, Giovanni Battista Storti, Mariella Fabbris, Lucilla Giagnoni, Enzo Toma, Gabriella Bordin, Patrizia Piccinini, Massimo Tradori, Mirko Artuso, Massimo Formia, Loredana Lanciano, Roberta Pian, Andreina Garella, Roberta Biagiarelli, Matilde Domestico, Davide Cantatore.
Debutto: Santarcangelo di Romagna, luglio 1988.