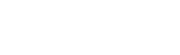“Bravo! Nol par gnanca che el recita.” Questa era la regola lapidaria con cui mia nonna giudicava un attore: è bravo! Non sembra neanche che reciti. Per contro, degli attori che non le piacevano, diceva con disprezzo: “No l’è bon! Se vede che ‘l recita.” Traduzione: non è capace! Si vede che recita.
A lei piacevano Cesco Baseggio, Lina Volonghi, Gino Cervi… adorava Eduardo De Filippo – “Anca se l’è un napuli” – (anche se è napoletano). La sua preferita, però, era Rina Morelli perché, diceva, “No la alsa mai la voze”: non alza mai la voce. Vi parlo di mia nonna perché questo insegnamento sintetico: Nol par gnianca che el recita, mi è sembrato sempre molto saggio. E credo ci aiuti a capire l’evoluzione che sta subendo la figura dell’attore, soprattutto in relazione al cinema, alla televisione e ai nuovi media. Un tempo, per farsi sentire fino in fondo al teatro bisognava “portare la voce”. Questo richiedeva grandi capacità polmonari.
Vent’anni fa ho avuto la fortuna di lavorare con Valeria Moriconi. Alla proposta di usare i microfoni per lo spettacolo che stavamo facendo, andò su tutte le furie: “Ho impiegato una vita a farmi il diaframma e adesso tu vuoi distruggermi tutto?”. Vent’anni fa stava finendo il millennio. Nella cultura dell’epoca prevalevano due atteggiamenti opposti: prepariamoci alla fine espiando le nostre colpe; oppure: godiamoci il tempo che ci rimane. Era qualcosa che avevano dovuto conoscere già alla fine del primo millennio, quando si pensava che allo scoccare della mezzanotte del novecentonovantanove sarebbe finito il mondo. Questa volta c’era l’aggravante del mille non più mille.
Ogni nuovo libro, ogni nuovo spettacolo, ogni nuova opera d’arte si annunciava come il gesto ultimo di un’umanità esausta. Gli intellettuali di spicco davano per compiuta la fine del romanzo, la fine del teatro, la morte dell’arte in genere. Dio era morto da un pezzo e uno storico americano, nel 1992, sancì la fine della storia. Il teatro ha tre fonti: il rito, il gioco, la narrazione. Il rito e il gioco, declinati in mille poetiche, erano all’origine di ogni proclama finale. In questo quadro catastrofico la terza fonte del teatro sembrava dimenticata o, piuttosto, inutile. La narrazione è affermazione del tempo. Se il tempo sta per finire cosa t’importa di affermarlo? La narrazione è conferma del passato e del futuro. Se sei convinto di non avere futuro, perché dovresti confermarlo? E se non hai un futuro, che te ne importa del passato? E se la storia è finita cosa ti rimane da raccontare? Per la nostra generazione, cresciuta al cospetto di grandi creatori di riti finali e di giochi mortali, che possibilità c’erano?
Ci rendevamo ben conto delle tragedie che testimoniavano i nostri padri. Ci scorrevano davanti agli occhi le loro visioni potenti di un’umanità offesa da Auschwitz, da Hiroshima, dai gulag. Nutrivamo grande rispetto per la loro angoscia: avevano tutte le ragioni di coltivarla e celebrarla. Certo, era un po’ frustrante essere giovani mentre tutto, intorno, stava per finire. Per fortuna c’erano anche “padri” come Peter Brook e Dario Fo, che continuavano a tessere grandi racconti. Infatti, già da qualche anno, un po’ clandestinamente, avevamo cominciato a frugare tra le macerie del Novecento. Ciò che si trovava erano frammenti, schegge di costruzioni precedenti che, però, reincollate da nuove tecnologie come la televisione, come Internet, sembravano ricomporre semplici forme di racconto. Nel teatro, in particolare, quello che sembrava riemergere era la trascurata terza fonte: la narrazione. La realtà si frammentava. Però scoprivamo che questi frammenti di realtà, riaccostati come nei puzzle, producevano scintille di senso, narrazioni, di tempo.
Blob, la popolare trasmissione televisiva inventata per affermare la perdita del senso, si rivelava l’affermazione del contrario: accostando frammenti a caso dello stupidario televisivo, non si evidenziava la perdita del senso, si producevano scintille di qualcosa che, in fin dei conti, era significato, senso. Sperimentavamo con sorpresa che non era vero che il tempo era finito. Oppure sì, magari era finito, però nulla vietava di fabbricarne di nuovo. E una possibilità di produrre tempo era raccontare il passato per costruirsi un futuro.
Prima c’era il “teatro di parola” che esigeva l’estrema, estenuata considerazione di ogni vocabolo: che ogni parola, in teatro, sia pronunciata come fosse l’ultima! Così si affermavano spettacoli monumentali, in cui le parole cadevano come macigni. Ci volevano intervalli lunghi tra l’una e l’altra perché si depositassero nell’anima dello spettatore. Quando ti travolgeva la parola successiva non avevi già più memoria di quella precedente: era paradossale, ma il peso della parola annullava il “discorso”, che si compone nella relazione tra le parole. Il teatro di parola, costringendo all’isolamento, alla solitudine, ogni singolo lemma, dilatava il tempo fino a dissolverlo. Per contro, c’erano grandi attori che innalzavano canti meravigliosi fatti di parole dilaniate, straziate. Contava l’andamento tonale, la modulazione virtuosistica, il canto: anche in questo caso il suono aveva la meglio sul senso. L’esito era conforme: entrambe le tendenze testimoniavano la perdita di significato del testo, che annunciava la catastrofe finale: mille non più mille.

Valeria Moriconi, dopo le prove, a cena, mi raccontava degli spettacoli storici di cui era stata protagonista, diretta da tutti i più grandi registi del secondo novecento. Lei era una vera e propria sacerdotessa del teatro di parola. Io cercavo di convincerla che i microfoni le avrebbero permesso una più ampia modulazione della voce, che avrebbe potuto aggiungere un’infinità di sfumature senza la costrizione di portare la voce fino in fondo alla sala.
Valeria Moriconi fu una delle mie prime fughe dal Laboratorio Teatro Settimo. Gli spettacoli che facevo col mio gruppo inseguivano una qualche ricomposizione del tempo. Non cercavamo più le profondità abissali di ogni parola, non ci interessava più solo il loro suono. Esploravamo i legami tra le parole. C’interessava molto il suono delle parole, il loro “canto”, ma perché serviva a riverberarne il senso. Il nostro non era più teatro di parola, ma “teatro di discorso”.
Valeria Moriconi era una donna di grande intelligenza, quando le tirai fuori il teatro di discorso capì al volo: “Tu vuoi che parli normalmente! Va bene! Ma comunque non servono i microfoni”. Dal giorno successivo le prove cambiarono. Parlava piano come Rina Morelli. Sarebbe piaciuta molto a mia nonna.
In quegli anni si affermava anche la “televisione di parola”. Sembrava il contrario del teatro di parola, ma a ben vedere l’obiettivo era lo stesso: celebrare la decomposizione del senso attraverso il dissolvimento del tempo. La “televisione di parola” era fluviali talk show in cui si chiacchierava all’infinito. Il vuoto pneumatico creato dalla massa specifica della parola teatrale si traduceva, in televisione, in un profluvio di vaniloqui che invece sottraeva peso al discorso, fino ad annullarlo.
Una sera Valeria Moriconi era ospite nel più popolare talk show dell’epoca. Il conduttore le chiese come era lavorare con un regista d’avanguardia (disse proprio così: d’avanguardia. Ero io). Lei rispose: “Va bene, mi piace, solo non vuole che reciti”.
Qualche mese dopo la tv trasmise uno spettacolo che avevamo fatto con Marco Paolini. Fu un grande successo. Credo che il successo, anche televisivo, del Racconto del Vajont, nascesse dalla sorpresa di una parola in equilibrio tra il senso e il suono. Il che generava un discorso immediatamente comprensibile. Ma dove la comprensione non era tolleranza indulgente e la comprensibilità non era facile accesso che banalizza. La comprensione per noi aveva un gusto arcaico, come il suono di lingue dimenticate. In genere riesce molto più facile capire invece che comprendere: è così che consumiamo le onnipresenti immagini pubblicitarie, così guardiamo distrattamente televisori, computer, iPhone e iPad. Comprendere era vedere fino a distinguere le piccole congiunzioni di una realtà che sembrava sbriciolarsi davanti ai nostri occhi. Ascoltare fino a sentire molte voci contemporaneamente: quelle che venivano da lontano, dalla televisione, dal web, ma anche quella che arriva dalle persone che ci sono accanto… Quella che viene da altri tempi, dal passato o dal futuro, ma anche quella parola che viene pronunciata qui, adesso.
Valeria Moriconi vide Il racconto del Vajont in Tv. Mi disse che aveva capito a cosa serviva il teatro di discorso, che le era piaciuto molto e si era commossa, ma che lei non avrebbe mai fatto niente del genere.
Credo che da quella sera, con uno spettacolo teatrale in prima serata televisiva, la narrazione abbia cominciato a riaffermarsi come strumento per produrre tempo, e quindi realtà. Che è poi un gesto antico come il mondo.
Ho insegnato molti anni alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, a Milano. I primi anni, 1988-1989, alle audizioni gli aspiranti allievi portavano grandi tirate enfatiche. Guardandoli mi veniva sempre da pensare ad un passaggio del Wilhelm Meister di Goethe che dice:
Si misero a recitar tragedie, poiché avevano sentito dire e credevano loro stessi che fosse più facile scrivere e rappresentare una tragedia che non una commedia: inoltre vi trovavano generalmente maggiori soddisfazioni perché nella commedia la banalità, il cattivo gusto e la mancanza di naturalezza saltavano subito agli occhi, mentre nella tragedia essi si sentivano degli esseri sublimi e non trovavano nulla che implicasse una critica all’enfasi, all’affettazione e all’esagerazione della loro azione tragica. Tanto più che nella vita comune avevano notato che molte persone insignificanti credono di guadagnarsi la stima degli altri con un contegno rigido e con smorfie ricercate.
Contegno rigido e smorfie ricercate era l’ideale di quei ragazzi. Parentesi: come succede che molti attori cinematografici di oggi quando fanno teatro riassumono quel vecchio ideale? Chiusa la parentesi.
Di insegnare alla Paolo Grassi ho smesso nel 2004, ma recentemente mi è capitato di tenere un seminario in una scuola di teatro. Nessuno presenta più grandi declamazioni, è raro trovare qualcuno che cerca di essere sublime senza trovare nulla che implichi una critica all’enfasi e all’affettazione. Molti giovani attori hanno la precisa consapevolezza che, nell’epoca del disincanto, all’immersione nel personaggio, all’immedesimazione, non trovi più uno spettatore disposto a credere. E penso di avere capito perché, ma ve lo dico dopo.
Prima vorrei dire che negli ultimi vent’anni questa, che chiamerei, per semplificare, “mutazione narrativa” dell’attore, ha prodotto festival frequentati da pubblici sempre più numerosi, readings che richiamano più gente del rock, conferenze con musica, proiezioni, danze, ecc. Se i numeri sul pubblico del teatro tengono, lo si deve soprattutto a queste forme di spettacolo di cui sono protagonisti giornalisti, filosofi, scienziati, ecc. Che parlano al pubblico in modo molto più diretto degli attori. A riempire i teatri nelle ultime stagioni sono telecronisti che raccontano le Olimpiadi del trentasei, scrittori che spiegano Leopardi agli adolescenti, giornalisti che mettono in scena vere e proprie commedie e recitano insieme ad attori, per non parlare, per contro, del grande comico che inventa il partito che governa la capitale. E lo fa usando con grande competenza e consapevolezza le tecniche attoriali maturate in decenni di palcoscenico.
Credo che questa ellisse potrebbe aiutarci a capire anche il fenomeno che i media chiamano, sbrigativamente, post-verità. Io ho la sensazione che la post-verità nasca da una manipolazione: certi politici intendono la narrazione come fabbricazione di verità a proprio uso e consumo. Così le parole narrazione, post-verità sono solo un modo di chiamare la vecchia propaganda. Si parla tanto di narrazione perché se ne fa pochissima.
Quando la narrazione è slegata dalla comprensione produce esiti inquietanti. La pratica del narrare significa riconciliarsi con il tempo, con il succedersi delle generazioni. È l’unica possibilità per uscire dalle secche della contrapposizione tra cogliere l’attimo e coltivare la memoria o progettare il futuro. Riconciliarsi con il tempo significa coltivarne la consapevolezza. La post-verità si costruisce su un’altra mistificazione, su un’altra parola bella, importante, di cui si ribalta il senso: percezione. La percezione di sé, degli altri, dello spazio e del tempo è l’obiettivo di una vita. Oggi, quando i media dicono percezione intendono la prima impressione di fronte ad un fenomeno. E i politici fanno leggi su queste impressioni. Leggi impressioniste. Ecco: credo che tutto questo abbia mutato radicalmente la figura dell’attore, il suo ruolo nel mondo. Ma prima di dire come mi sembra mutata e quale credo potrebbe essere questo ruolo ho bisogno di fare un’altra considerazione.
Riguarda un fenomeno parallelo a quella che chiamavo, per semplicità, la “mutazione narrativa” ed è il “teatro dei non attori”. Vent’anni fa si cominciarono a mettere in scena disabili psichici e fisici, detenuti, immigrati. Era una necessità che rispondeva alla stessa insofferenza verso la finzione che ci spinse a tornare alle fonti del teatro, soprattutto alla narrazione. Questa precisazione mi serve per introdurre quello che, mi sembra, stia accadendo. Per spiegare perché le nuove tecnologie costringono l’attore a rivedere in profondità il proprio ruolo.
Parto raccontandovi di Nadia. Quattro anni fa ho lavorato a Milano con 11 disabili, psichici e fisici. Alcuni erano tranquilli e disciplinati. Altri non avevi la minima idea di quello che avrebbero detto e fatto l’attimo successivo. Una di loro si chiama Nadia. Nadia è alta un metro e trenta, magra come un chiodo. Gli psichiatri dicono che ha il morbo di Basedow associato ad una sindrome psicorganica. Parla forbitamente. Usa termini come corroborante, incantevole, seducente… Solo che li ripete all’infinito. Per esempio: “Gabriele, Gabriele, Gabriele, Gabriele, mi offri qualche cosa di amaro? Qualche cosa di amaro, qualche cosa di amaro, amaro, amaro, amaro… Un caffè, un caffè, un caffè, una buona, ottima, aromatica, corroborante tazzina di caffè, ma amaro, amaro, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente amaro…”.
Nadia è una che può tacere per tutto un pomeriggio o non smettere un attimo di parlare. Colleziona rossetti. Non lo mette spesso, il rossetto, ma chiede a chiunque di portargliene un paio, specificando la gradazione di colore. Può raccattare in un giorno anche venti o trenta rossetti. Incontra una signora e le dice: “Che bel rossetto, che colore incantevole, incantevole, incantevole, che bel colore incantevole… Un colore veramente, veramente, veramente, veramente seducente, veramente affascinante, affascinante, af – fa- sci- nan –te, te, te, te… Ce l’hai qui il rossetto? Ce l’hai qui?… Me lo regali?”. E le signore glielo regalano.
Lei, Nadia, un giorno ha fatto una cosa pazzesca. Ha dispiegato un flusso di coscienza di mezz’ora, e noi siamo rimasti secchi a guardarla e ad ascoltarla. Parlava con una proprietà di linguaggio che comportava l’uso di espressioni come “Non posso assumere carboidrati perché voglio un pancino veramente piatto, un affascinante, seducente, provocante pancino veramente piatto, veramente, veramente, veramente pi – at – to, tto, tto!”. Usava metafore e metonimie, ossimori come: “La mia casa, la mia casa, la mia casa, la mia nuova vecchissima casa, la mia nuovissima vecchissima casetta… la mia amata, amatissima casa, la mia amata odiatissima casa”. Di fronte a Nadia che faceva fluire la propria coscienza ho ripensato a quanto ci ho lavorato sul flusso di coscienza. A quanti flussi di coscienza abbiamo provato a scrivere con Marco Paolini, con Laura Curino, con Lella Costa, con Arianna Scommegna, con Stefania Rocca. Il finale dell’Ulisse di Joice è sempre stato un’ossessione per me. Ho cercato di metterlo in scena non so quante volte. E Céline, che cercava di scrivere come i pensieri che ti scorrono in testa. Ecco: di fronte a Nadia che parlava scompariva tutto. Non c’era scrittura dietro alla sua presenza. Tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, tutto quello a cui potevo pensare diventava, irrimediabilmente, “troppo scritto”.
Ho cominciato parlandovi della narrazione perché narrando ritrovavo un rapporto con il tempo nel suo fluire. Mi interessava produrre tempo: ero convinto che tutto il tempo non raccontato è tempo sciupato. Per questo ci volevano attori/autori consapevoli della propria presenza in scena. Produrre tempo è sempre bello e necessario. Però adesso mi affascina veramente, veramente, veramente, ve – ra – men – te, te, te, stare dentro al tempo. Per questo ci vogliono persone reali, che sono esse stesse tempo. Da un po’ nutro un senso di disagio di fronte alla gran parte del teatro che vedo, ma anche di fronte al cinema, perché li trovo sempre troppo scritti. Trovo sempre tutto troppo scritto.
Il professor Gerardo Guccini, ad un convegno di qualche anno fa, citava una frase di George Sand che mi ha aiutato a comprendere questa sensazione: scriveva Sand che “un giorno, tutte le persone che saranno in grado di recitare, reciteranno”. Ecco: credo che sia arrivato quel giorno. Oggi sono molte di più le persone che fanno teatro di quelle che vanno a teatro. Sembra un paradosso, ma se contate i gruppi spontanei, le filodrammatiche, i gruppi scolastici, ma soprattutto l’utilizzo che del teatro fanno le aziende, gli SPRAR, gli ospedali, l’ultima moda è la medicina narrativa… Insomma la cosa non è paradossale, è la realtà. Succede anche per la scrittura, per la fotografia, per il cinema… Con i nostri iPhone produciamo continuamente immagini e video, molti dei quali non godranno mai della grazia di uno sguardo. Credo che il gesto successivo alla narrazione debba fare i conti con tutto questo. Una chiave per fare i conti con tutto questo me l’ha suggerita un piccolo saggio della professoressa Angela Albanese, che dice:
In un libro del 1984 intitolato Le storie che curano James Hillman parla di quanto sia importante nella psicoterapia curare non tanto il paziente, quanto le storie che questi racconta su se stesso. È vero infatti che una persona inizia un percorso terapeutico portando con sé un problema o un sintomo, ma è altrettanto vero che ciò che il terapeuta ascolta non è il dolore psichico ma la sua narrazione. Le storie dei pazienti, il modo e lo stile dei loro racconti sono per Hillman importanti quanto i sintomi, a patto che non si pretenda di tradurli immediatamente in linguaggio clinico o specialistico, ma ci si sappia porre in attenzione, per poi provare a ri-raccontarli, arricchendoli o impoverendoli, suggerendo elementi che li completano o che li presentano al paziente sotto una luce diversa da quella data nel suo racconto. Per accostare le narrazioni occorrono la pazienza di ascoltare attentamente, la capacità di proporre un’altra storia che possa aggiungere senso ulteriore a quella presentata e l’umiltà di non essere un analizzatore esterno della storia di un altro. Ascoltare le storie che curano e che hanno bisogno di cura, che rassicurano e che hanno bisogno di essere rassicurate vuol dire sapersi porre – in attento servizio […] entro una realtà immaginativa –.
Nel secolo scorso i grandi maestri del teatro hanno elaborato pratiche per gli attori che sembrano corrispondere perfettamente alla descrizione di Hillman. Queste pratiche, quindi, si possono estendere a tutte le persone. Il teatro è, sostanzialmente, “presenza”. Attore e spettatore sono presenti nello stesso tempo e nello stesso spazio. Quindi chi parla può ascoltare chi ascolta: così si genera un circuito che può essere messo al servizio della conoscenza di sé e degli altri. Per “gestire” questo circuito gli attori devono essere “presenti a se stessi”. Devono potersi vedere e sentire in modo profondo.
Questa conoscenza si sviluppa attraverso pratiche che possono derivare dalle danze popolari o dallo yoga, dalle tecniche vocali delle diverse culture, dalle patiche meditative orientali o dagli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola.
Queste pratiche, che per Stanislavskij e per Mejerchol’d, nei primi decenni del Novecento, erano “allenamento dell’attore”, con Grotowski cominciano ad estendersi alla cura della persona e con Giuliano Scabia, che porta il teatro nello spazio degli scontri, intervento sociale.
Non sono solo gli attori ad aver bisogno di una conoscenza profonda di se stessi e degli altri per stare in scena: tutte le persone ne hanno bisogno per stare al mondo. Se i conduttori televisivi applicassero a sé e agli altri queste pratiche, che vengono dal teatro, credo che in giro ci sarebbe un po’ meno post-verità e un po’ più realtà. Le tecniche del teatro si prendono cura della persona da sempre. La tragedia, nella Grecia classica, era il luogo dell’incontro della comunità. Era la sede della pratica democratica. Il dibattimento nell’aula del tribunale fino ai talk show della televisione di oggi affondano le radici nel teatro greco, incubatore delle società, delle comunità. Lo psicodramma, utilizzato dalla psicanalisi da decenni, nasce dalla scena in cui Amleto mostra allo zio l’assassinio del padre, innescando un percorso di verità. Le pratiche del teatro supportano la socialità, la medicina, l’educazione. Perché alla base di queste necessità umane c’è sempre la capacità di stare. Di abitare consapevolmente il proprio tempo e il proprio spazio. In autonomia o in relazione agli altri esseri umani.
Nel secolo scorso era di moda un dibattito che contrapponeva il teatro e lo spettacolo. Erano tempi di contrapposizioni: il teatro contro lo spettacolo, l’arte contro il mercato, il processo contro il prodotto. Quello che è accaduto negli ultimi anni è una sorta di “compensazione”. Per capirci: la globalizzazione marcia sui McDonald, ma contemporaneamente nasce e cresce SlowFood. Credo che nel teatro stia accadendo qualcosa del genere: i maestri del Novecento hanno fondato pratiche che comprendevano processi e prodotti. Oggi: da una parte lo spettacolo sta assumendo dimensioni impensabili fino a pochi anni fa. Dall’altra il para-teatro, il teatro che include, anziché escludere, assume dimensioni forse insperate dagli stessi maestri che li hanno fondati.
Le tecnologie permettono uno sviluppo dell’entertainment che coinvolge fisicamente lo spettatore. Mutano radicalmente i tempi e gli spazi dello spettacolo. È una bella sfida governare queste esplosioni spettacolari, che non sono più ambienti, ma iper-ambienti. Non più ambientazioni in scala ridotta, ma fenomeni di incremento della scala, realtà aumentata. Tutto molto divertente e appassionante. D’altra parte il teatro, incalzato dalla tecnologia, può finalmente permettersi davvero di abbandonare all’< i suoi caratteri più spettacolari per rivolgersi alla cura della persona.
Oggi c’è molta più gente che fa teatro, che danza, di quanta non vada a teatro, dicevo: è una buona notizia! Ormai è pratica comune l’impiego delle tecniche teatrali per l’integrazione dei disabili, per la narrazione medica, per il recupero delle periferie disagiate. Il lavoro dei più significativi artisti contemporanei non percepisce più l’azione sociale come un dovere ideologico o una caritatevole elargizione. L’inclusione è ormai la poetica di molti tra gli attori, registi, drammaturghi più innovativi.
Questa realtà comporta un mutamento radicale delle figure stesse dell’attore, ma anche del regista e del drammaturgo. Un loro ripensamento profondo.
Il grande interprete di culto, l’esclusivo oggetto del lusso popolare, come Valeria Moriconi, avrà sempre il suo posto nel cuore del grande pubblico, continuerà a parlare ai propri spettatori. Ma già da decenni questo fenomeno riguarda più che altro il cinema, la musica, lo sport. In teatro, gli spettatori, potendo essere sempre più attivi, genereranno, stanno già generando, nuove figure di attori indirizzate all’azione con le persone. Questi attori non parlano agli spettatori, agiscono con interlocutori consapevoli.
Naturalmente questo porta con sé un pericolo: se, come diceva George Sand, tutti possiamo fare il teatro non servono più gli artisti. Siamo tutti artisti. Non è così. L’arte, oltre a generare forme, nasce sempre più dall’inclusione. La bellezza nuova nasce dalla comprensione di artisti, educatori, operatori sociali, medici, psicologi… persone.
Non so cosa avrebbe detto mia nonna di tutto questo. Lei era nata nel 1901. So che per tutto il Novecento i grandi attori, i maestri del teatro hanno inseguito l’invocazione del padre, che chiude i Sei personaggi di Pirandello: Ma che finzione! Realtà, realtà, signori! realtà!

Riferimenti bibliografici
J.W. Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato, Adelphi, Milano 1976.
J. Hillman, Le storie che curano. Freud, Jung, Adler, Raffaello Cortina, Milano 1996.