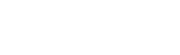Nell’estate del 1989 Laboratorio Teatro Settimo proseguì il proprio progetto Dura madre mediterranea scegliendo non tanto di allestire un nuovo spettacolo – dopo le prime due tappe che coincisero con la messa in scena prima di Nel tempo tra le guerre, poi di Istinto occidentale, che avevano debuttato, rispettivamente, l’estate precedente al festival di Santarcangelo e nel dicembre 1988 – bensì di prendersi tempo e di vivere due soggiorni di studio e di lavoro, il primo a Montalcino, in Toscana, dall’1 al 16 luglio, e il successivo a Drena, in provincia di Trento, dal 24 luglio al 6 agosto.
Due prolungati periodi di residenza cui parteciparono, oltre al nucleo artistico della compagnia, attori, drammaturghi, registi, tecnici e ospiti vari, questi ultimi in qualità di “osservatori” speciali. Fra di essi citiamo almeno Gerardo Guccini e Marco Baliani, che raccolsero poi le loro significative “impressioni” in due saggi – intitolati rispettivamente Il personaggio dell’attore, una drammaturgia perpetua e Ri-narrare il mito – pubblicati su Il castello di Elsinore, anno III, 7, 1990. Sullo stesso numero della rivista, edita dall’Università di Torino, fu pubblicata parte del diario – la versione completa è reperibile on-line – che in occasione di entrambi i soggiorni tenne Bruno Tognolini.
Ma quali erano gli obiettivi dei due soggiorni?
Gabriele Vacis, in un saggio significativamente intitolato Otium e negotium e pubblicato su Teatro e storia (a. V, n. 1, aprile 1990, pagg. 153-159), sottolineava come in quel momento per Laboratorio Teatro Settimo non fosse importante tanto lavorare per realizzare un nuovo spettacolo, bensì prendersi del tempo per inventare una forma del raccontare, una drammaturgia «non necessariamente tutta funzionalizzata allo spettacolo» bensì «dilatata nel tempo, capace di assumere più autori all’interno di una situazione mutabile ma coerente nel processo di produzione». S’intendeva, dunque, analizzare e mettere in discussione le forme convenzionali di pensare e fare il teatro, forzandole e modificandole, anche tornando alle origini – il titolo del soggiorno rimanda proprio a una ricerca delle origini, quelle dei figli del Colonnello protagonisti di Nel tempo tra le guerre ma anche quelle di una vocazione teatrale ognora ridiscussa e ripensata.
Le giornate erano dense e lunghissime: alla mattina, ricorda Tognolini, «tutti gli attori cercano il respiro comune», compiendo insieme vari esercizi, mentre nel pomeriggio essi studiavano i propri brani ed entrava in funzione quello che venne definito “gabinetto drammaturgico”, che consisteva in «una stanza piena di libri, carte, figure, con un computer che rende più comode e svelte le scritture e l’intreccio delle drammaturgie quotidiane». Le serate – e sovente anche le nottate – erano occupate dai cosiddetti “giornalieri”, un termine tratto dal vocabolario cinematografico per indicare quelle lunghe e vivificanti ore in cui «ognuno degli attori mostra il lavoro del giorno a tutti gli altri».
Si trattava di quelle che vennero definite “deposizioni” da parte degli attori-personaggi e che Marco Baliani, ospite nel corso del soggiorno a Drena, descrisse come forme di comunicazione che «al di là del contenuto e delle sostanze dette, erano a volte una disperata ricerca di dignità da parte dell’attore nei confronti del personaggio, come dicessero nonostante tutto: guardate, io sono, esisto. Di qui l’immagine di una lotta ancora da fare, un allenamento per essere pronti dentro il proprio involucro».
L’invenzione di una nuova drammaturgia, dunque, non coinvolgeva soltanto registi e autori ma era anche – e forse soprattutto – drammaturgia dell’attore che, come sostenne Gerardo Guccini, è qualcosa in costante riformulazione e mutazione, “perpetua” e caratterizzata, insomma, dalla “continuità”.
Una consapevolezza, quest’ultima, acquisita anche grazie all’esperienza dei due soggiorni Ab origine, durante la quale Laboratorio Teatro Settimo comprese come i testi letterari scelti quali fondamenta del potenziale spettacolo che avrebbe dovuto concludere il progetto Dura madre mediterranea non potevano essere utilizzati agendo su di essi con i consueti strumenti di analisi letteraria, bensì incrociandoli con narrazioni autonome e personali. La scoperta più sensazionale e determinante per la “poetica” sviluppata in seguito dalla compagnia che venne raggiunta al termine di quei due soggiorni fu proprio che «il senso dell’esperienza non andava cercato nell’utilizzo dei racconti, nella loro trasformazione in forma e spettacolo, ma nel nesso fra queste nostre storie e l’abitare un luogo in cui scorreva quotidianamente un mite flusso di teatro, ritrovato come luogo dell’essere piuttosto che dell’apparire» (G. Vacis). La letteratura veniva fatta reagire con l’essere più profondo degli attori e si trasformava in narrazione, inedita e vera.
NB: L’immagine utilizzata è di Lucio Diana. Il titolo dell’installazione/performance era Tienanmen giugno 1989.
Laura Bevione