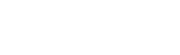STEFANO LOCATELLI (Sapienza Università di Roma)
Intervento al Teatro Biondo di Palermo al convegno "Presente e futuro della creazione contemporanea"
Chi sono gli under 35? E perché proprio under 35? E gli under 45 allora? Quand’è che uno smette di essere giovane? Forse però la domanda oggi potrebbe essere: quand’è che uno comincia a essere abbastanza giovane...? Sui giornali capita di sentir definire “giovani registi” (o artisti in generale) persone ormai ultra quarantenni (finanche a volte quasi cinquantenni). Chi esce dall’Accademia, dalle scuole di teatro, o anche dall’Università giustamente si chiede: Ma allora io adesso che faccio, mentre aspetto di diventare giovane (cioè over 40)?
Uno degli obiettivi che ci poniamo nella nostra università, nell’ambito dei corsi di laurea in Spettacolo della Sapienza, è di formare o almeno introdurre ai modi e processi produttivi a 360 gradi (facciamo per esempio anche laboratori di riprese video per lo spettacolo dal vivo), in un contesto in cui naturalmente prevale lo studio storico e teorico. Rileggere e forse comprendere le teorie e la storia (saper fare le domande giuste ai documenti storici) alla luce delle pratiche è alla base del nostro approccio agli studi teatrali. Un aspetto su cui stiamo molto lavorando è il rafforzamento dei corsi che hanno a che fare con la produzione e la organizzazione dello spettacolo dal vivo. Quest’anno siamo riusciti anche a far partire, per la prima volta in Sapienza, un master in Economia e organizzazione dello spettacolo dal vivo. Per la verità pare vi sia una certa difficoltà a trovare un numero adeguato di studenti realmente interessati a frequentare master di questo tipo (quest’anno abbiamo preso dieci persone, poche ma molto buone…). Ho anche dovuto un po’ convincere un candidato ammesso al master, per altro dotato di un curriculum notevole (e già di sicuro interesse per i molti che sono alla ricerca di bravi organizzatori), indeciso se confermare l’iscrizione o no, perché forse voleva fare l’“artista” e non lo “sterile organizzatore”… In questi casi basta anche solo raccontare chi era, cosa ha fatto, e quale incidenza culturale e pure artistica ha avuto Paolo Grassi sul teatro italiano, per aiutare le persone a fare quello che veramente vogliono fare. Di sicuro c’è un grande e diffuso desiderio di fare gli “artisti”. Ma a volte sembra più una idea artistoide di artista.
Artisti “puri”, artisti “a ogni costo”, artisti per l’arte ma anche “per tutti”, “indipendenti”, “interculturali” e “popolari”, “poli-multi-inter-disciplinari”, se possibile impegnati a ridisegnare un presente ostile e a progettare il futuro al di fuori degli spazi e delle regole convenzionali, in “beni comuni cantieri di rigenerazione urbana”. Certo, abbiamo anche assistito negli ultimi anni (se non decenni ormai) a un certo ubriacamento dell’estetica e della teoresi. Un amico tedesco mi raccontava ormai dieci anni fa che molti, troppi gruppi giovani in Germania facevano teatro letteramente con il libro di Lehmann (Postdramatisches Theater, 1999) in mano. Oggi succede anche in Italia: “Facciamo teatro post-drammatico”. Un po’ come la Poetica di Aristotele diventata normativa nel Rinascimento italiano. Ma peggio, perché in quel caso la distorsione prospettica dovuta a un intervallo di 1200 anni di storia si coniugava alla necessità di “reinventare” il teatro moderno. Lehmann usato come manuale di norme ha invece molto a che fare con l’incapacità contemporanea di distinguere tra fenomenologie e modelli (che forse è un po’ quel che fanno anche certi bandi europei quando tendono a prescrivere le condizioni e finanche le finalità della creazione artistica; ma in generale anche l’incasellamento ministeriale tipicamente italiano dei fenomeni teatrali, con tanto di algoritmi, è probabilmente parte della stessa logica).
Scambiare fenomenologie per modelli è una delle forme di barbarie culturale più aberranti del nostro tempo. Forse parliamo di contesti in cui non esiste propriamente un MERCATO? Di certo esiste un mercato per certi aspetti “drogato”, che riceve soldi pubblici, in teoria, per le produzioni, e reclama, anche giustamente, sempre più soldi per le produzioni. Tutto questo è pure sacrosanto, cioè chiedere che lo Stato tuteli e sostenga l’Arte in tutte le sue forme. Però dalle modalità di intervento della mano pubblica, e anche troppo spesso dai discorsi e dalle richieste precise degli operatori, pare che tutta questa richiesta e volontà di sostegno dello Stato sia fondata su una illusione sempiterna che l’offerta di spettacolo (ovviamente di qualità, d’arte, ecc. ecc.), cioè la produzione, possa in qualche modo anche generare la domanda di spettacolo. Cui si accompagna un’altra illusione, cioè che debbano e possano essere i teatri, a latere delle produzioni, a generare “domanda” occupandosi della “promozione del pubblico” (per altro terminologia propria del marketing, e che alla fin fine del marketing – ovvove! – assume molte caratteristiche). Basterebbe rileggersi ogni tanto John Maynard Keynes: non è l'offerta che crea la domanda (come sosteneva la legge di Say, che qualcuno ancora oggi sembra prendere per buona), ma è la domanda che genera l’offerta (J.M. Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, libro I, cap. III), come avviene in tutti i fatti umani che hanno a che fare con la componente economica che sta alla base di qualsiasi scambio (anche di beni immateriali). Sarà in quest’ottica centrale la questione del PUBBLICO. Se non c’è una comunità, locale o nazionale, che (per mille svariate ragioni a partire dall’assenza del teatro dall’orizzonte culturali dei cittadini) domanda spettacoli, non ha senso produrre sempre di più, o in modo diverso, o proponendo gruppi “ggggiovani”, pensando che poi il pubblico “gggiovane”, o in attesa di diventare giovane, decida di andare a teatro. (Del resto, non è che se un barista, accorgendosi che il suo bar è sempre vuoto, si mette a fare un caffè dietro l’altro e li posa in fila sul bancone del bar, allora entreranno all’improvviso dei clienti a bere quei caffè…).
Da questo punto di vista, non ha molto senso nemmeno fare la promozione del pubblico, pensando che essa significhi anche formazione del pubblico. Di base, la formazione del pubblico è un compito inevitabilmente al di fuori della portata di chi produce spettacolo dal vivo, e dovrebbe essere considerato inaccettabile come compito che surrettiziamente lo Stato italiano tende a demandare alle istituzioni teatrali. Un conto è la promozione (e il marketing nelle sue più varie forme, che spesso si sente la necessità di mascherare e a volte giustificare con qualche principio di etica comunitarista), un conto è la formazione. Forse il Teatro alla Scala dovrebbe occuparsi anche di insegnare gratis musica a tutti i suoi potenziali spettatori?
Del resto, sarebbe come pretendere che la Fiat, oltre a produrre e promuovere automobili, debba anche occuparsi di insegnare a guidare ai potenziali acquirenti delle proprie auto. Per quanto riguarda gli ambiti dell’arte e della cultura riconosciuti dallo stato come di interesse pubblico, la formazione dei cittadini ai fondamenti dei linguaggi, della storia e delle forme dell’arte non può che essere di competenza dello Stato, anzitutto attraverso quel primario veicolo di formazione che è garantito dalla Costituzione, cioè la Scuola. Ma, purtroppo, non si sente abbastanza, anche da parte degli operatori teatrali, chiedere un deciso intervento politico sulla scuola in generale, dove si dovrebbe (come avviene in molti altri Paesi), introdurre il teatro come materia curricolare.
Lo stesso in fondo vale anche, e forse a maggior ragione, per la musica: siamo la patria del melodramma, dell’opera lirica, del pianoforte (ecc. ecc. ecc.) e dunque più che giustamente spendiamo centinaia di milioni di euro del FUS, e non solo, per finanziare la musica e l’Opera ma, al contempo, nelle nostre scuole (e il tutto per altro limitato sostanzialmente alla primaria e alla scuola media) si fa poca storia e pochissimo ascolto musicale e, quel che è peggio, spesso si impara a odiare la musica perché costretti a zuffolare quattro note in classe con l’odioso piffero (detto anche flauto dolce); quando l’esercizio dello strumento si protrae a casa, spesso l’odio per la musica viene alimentato pure tra i genitori e i vicini di casa. Non basta certo pensare al teatro nella scuola alla maniera della cosiddetta “Buona Scuola” (e relative linee guida), ovviamente a “costo zero”, che alla fine ha continuato a relegare, quando va bene, una attività che doveva diventare “curricolare” all’orario post-pomeridiano da dedicare alle attività facoltative (i bambini stanno già a scuola dalle 8.30 alle 16.30, e io stesso, che pure insegno una cosa che si chiama Storia del teatro all’Università, troverei brutale lasciare mia figlia a fare il laboratorio teatrale ancora tra quattro mura dalle 17 alle 19; preferisco mandarla a buttarsi tra le pozzanghere al parco, o a giocare a Tennis, come per altro suggeriva Mejerchol’d ai suoi attori).
In fondo, si tratta di una questione di educazione dei cittadini ma anche di generale preparazione ai linguaggi del teatro e della musica e dell’arte, che avrebbe come ricaduta naturale proprio la domanda di teatro, la creazione di un pubblico, dunque di una domanda e di un mercato naturale per il cosiddetto spettacolo dal vivo. Tuttavia, in altro senso, esiste già una forte domanda di teatro. Una strabordante domanda e necessità di teatro, dei mezzi del teatro, in tutti quei contesti in cui si sente l’esigenza forte di costruire o ricostruire relazioni, in contesti di cura, nella formazione, anche nella politica… Il fatto è che questa necessità di teatro spesso non viene riconosciuta e nominata come tale. E rimane (troppo spesso anche tra gli addetti ai lavori) la confusione tra teatro e spettacolo.
La nostra sfida dovrebbe e vuole essere anche formare persone che, col teatro, diventino cellule attive all’interno della società. Non solo produttori di spettacoli o artisti, tantomeno artistoidi.